
Diario di un’estatediFederico Raminelli |
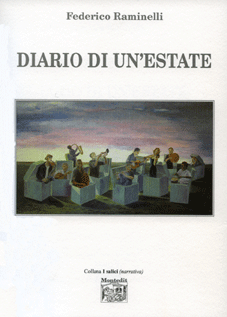
Collana "I Salici" - I libri di Narrativa
15x21 - pp. 372 - Euro 16,50
ISBN 978-88-6587-0266
Clicca qui per acquistare questo libro
In copertina: «Per fortuna che c’è la Musica» dipinto di Daniela Cristina Anna Iannace
All’interno: fotografie dell’autore
La vita rivista con l’esperienza del passato, delle mille vicissitudini, emozioni, sensazioni, rimpianti, nostalgie, suggestioni. Un uomo a metà della sua vita racconta un’estate della sua vita.
Ecco il ricordo relativo al Monginevro con l’amante e la rivisitazione dei momenti legati alla forte passione con pagine memoriali altamente sensuali. Poi i ricordi relativi alla Sardegna nel paese di Gairo, in compagnia delle figlie ed uno sguardo attento alla terra sarda con le sue mille contraddizioni, le sue molteplici chiusure in alcune prospettive esistenziali. Poi il ricordo relativo a Bologna con l’ex moglie e le visite alle sette chiese con un percorso nella città che recupera storia ed emozioni. Infine il ricordo relativo all’Albania con alcuni amici. Una settimana a Scuteri, in una realtà diversa e l’Albania rimane nel cuore.
Alla fine una sorta di presa d’atto, un resoconto finale.
Prefazione
Nel romanzo dal titolo “Diario di un’estate”, Federico Raminelli racconta, come in un viaggio umanamente disvelatore, gli avvenimenti e gli stati d’animo di un’estate vissuta dal protagonista.
Il romanzo è scandito in quattro tempi che riconducono al periodo estivo del protagonista come a rivivere le sue esperienze: i frammenti esistenziali vengono rivisti con la consapevolezza del presente e, al contempo, con un’attenta propensione a scrutare il complesso mondo interiore.
Il primo tempo fa riferimento ai momenti trascorsi sul Monginevro, nella prima metà del mese di luglio, in compagnia dell’amante con alcune pagine fortemente intrise da recuperi memoriali e slanci sensuali legati alla passione vibrante e travolgente d’un folle desiderio che esalta il piacere fino all’estasi suprema.
Il secondo tempo vede il protagonista di questo “diario” nella terra di Sardegna, a Gairo Sant’Elena, con le figlie Adriana e Paola: tra le mattinate in spiaggia, l’escursione in battello lungo le spiagge della costa orientale e visite alle bellezze naturali del luogo.
Il terzo tempo fa poi riferimento al tempo trascorso a Bologna durante una gita in famiglia con la presenza dell’ex moglie Anna e lunghi itinerari nella città.
Il quarto tempo, infine, è il periodo trascorso dal protagonista in Albania, a Scutari, in compagnia di alcuni amici ed è un momento di attenta osservazione della realtà di quella terra, della sua cultura e dei suoi costumi.
Si arriva così alla fine dell’estate, al ventitré settembre, come in un lento naufragare nel mare delle illusioni, nel turbinio dei pensieri di un’estate e la necessità di formulare una conclusione dopo aver scandagliato ed analizzato gli eventi: lo stato d’animo che annuncia l’autunno riconduce alla “tristizia”, l’arcano che domina la vita del protagonista con la presa d’atto che la ricerca personale è destinata a continuare.
Nel romanzo di Federico Raminelli, non a caso, la storia personale si interseca con riferimenti storici, culturali e sociali ma sempre emerge dominante l’universo emozionale del protagonista Giovanni: la sua figura è quella di un uomo di cinquant’anni che deve fare i conti con l’inesorabile scorrere del tempo. Da questa obbligatoria evidenza emergono il disincanto davanti al crollo delle certezze familiari, economiche e fisiche: la fine del matrimonio, il lento distacco da parte delle figlie, il fisico che inizia a creare alcuni problemi. L’immagine di un uomo che si avvia verso un “tramonto dorato”, permeato nell’animo da una tristezza soffusa (la “tristizia” alla quale fa riferimento nelle ultime pagine del romanzo), semplice e chiaro segno delle contraddizioni della sua vita. Un uomo che sente di “essere spettatore”, incapace di affrontare gli eventi con entusiasmo, quasi in una condizione che lo fa sentire “inadeguato”, velato di scetticismo e chiuso nell’autoironia, asserragliato nel “suo” mondo.
Lo spiraglio esistenziale che riesce ad illudere il protagonista e farlo sentire “ancora giovane” è la forza dirompente della sua amante: l’amore per Eva, donna giovane “straripante di bellezza, fascino ed allegria”. Una donna che “non amava voltarsi indietro”, “protesa al futuro”: la sua figura femminile rappresentava l’illusione d’un momento, folgorazione e dolce frutto da gustare sapendo che “ogni esperienza doveva essere consumata”.
Ecco allora che, durante i mesi dell’estate, si assiste ad un’analisi profonda ed acuta degli eventi che hanno contrassegnato il cammino: tutto viene analizzato e diventa sostanza delle esternazioni con la considerazione che “non si può fuggire da se stessi” ed è molto faticoso “rimettersi in gioco”.
Nella sua mente emerge la consapevolezza che ardua impresa è cercare appoggio all’esterno di se stessi e, in ultima analisi, diventa difficile “trovare un sostegno all’esterno”: alla fine, la presa d’atto che “ogni spiraglio restava aperto”.
Nella trama del romanzo si alternano passaggi permeati da ironia, visioni della realtà ed eventi vissuti tra serietà e divertimento, eppure sempre avvolti da una velata amarezza e da un costante riferimento alla dimensione spirituale. Lo sguardo nei confronti del mondo è sempre “scrutatore”, “indagine personale” che si inserisce anche nella sfera del ricordo. Tutto è passato al vaglio d’una personale lente d’osservazione che esalta la più labile percezione e fortemente avvertita è la rivisitazione delle esperienze della propria vita.
Esemplari a tale proposito le considerazioni del protagonista sul “passato”: i ricordi del passato “non possono soddisfare”, da questa evidenza la necessità di “resettare tutto ciò che di bello e piacevole si era verificato”, il “tempo andato altro non è che memoria, destinata ad essere cancellata dalla mente”.
“Diario di un’estate” di Federico Raminelli è un romanzo di indubbia qualità e di evidente spessore letterario. La strutturazione del testo è architettata, come già scritto, in quattro tempi che scandiscono il periodo di un’estate vissuta dal protagonista in quattro luoghi diversi ed è sostenuta da notevole capacità di raccontare le relative vicende che si susseguono seguendo lo scorrere della stagione estiva.
Nella lettura dell’opera si possono evidenziare alcune caratteristiche e riscontri positivi: la padronanza nella rappresentazione del protagonista e dei vari personaggi unitamente alla dovizia nella descrizione delle diverse ambientazioni con riferimenti storici, culturali e sociali. Si rileva poi la capacità di unire le scene grazie ad un filo conduttore sapientemente impostato che funge da legante per le numerose riflessioni da parte del protagonista, unitamente all’efficacia nel rendere narrativamente interessanti gli stati d’animo del protagonista e delle figure che ruotano intorno a lui.
L’utilizzo di un lessico sempre appropriato e la fluidità nella lettura denotano uno stile personale che l’Autore possiede nelle sue corde e riesce a trasfondere nella stesura del romanzo.
Federico Raminelli è sempre attento a rappresentare nel modo prescelto la figura dominante del protagonista, le caratteristiche dei personaggi, le vicende vissute, le immagini osservate, il profondo senso religioso che pervade numerose pagine del romanzo e le atmosfere coinvolgenti avvertite nel profondo dell’animo.
Il “diario di un’estate” del protagonista viene presentato al lettore e poi analizzato e scrutato nei minimi dettagli oltre all’inserimento di divagazioni narrative di varia natura eppure si capisce che qualcosa viene lasciato in sospeso come un sottile mistero da decifrare: tale presunzione di svelamento avverrà, solo in parte, nelle pagine finali.
La “stagione dell’estate” assume così una funzione simbolica che sottende all’intera narrazione: nascondendo eppure rivelando, mostrando eppure celando.
In questo caso l’estate diventa un simbolo liberatorio, “stagione amica” che avvicina alla consapevolezza di sé, anche se l’ultimo giorno d’estate non può essere, né può rappresentare, una presa d’atto definitiva e non diventa ultima ratio ma, inevitabilmente, conduce “soltanto” ad una nuova stagione della vita del protagonista.
Federico Raminelli riesce a rappresentare ciò che più interessa la sua sfera d’indagine e lo fa con originalità ed innegabile incisività, certamente con coraggio e con una scrittura pervasa da volontaria provocazione e vena ironica: scavando nel profondo della sua coscienza sembra voler superare le filosofiche questioni di confine, i segnali e i sintomi che riaffiorano durante la vita.
In ultima analisi, si può ben sottolineare come l’intenzione dell’Autore, tra il serio ed il faceto, sia raccontare le contraddizioni del nostro vivere, le dicotomie e le sfaccettature della vita: la visione globale è sempre in equilibrio tra le molteplici verità dell’esistenza con le quali ogni essere umano deve fare i conti. E Federico Raminelli mette in campo la sua propensione a penetrare tali antinomie e contrasti: con profonde riflessioni e “ritrovata” saggezza.
Massimo Barile
Diario di un’estate
Giovanni
Mi chiamo Giovanni. Mi chiamarono Giovanni i miei genitori, in un freddo e lontano febbraio di mezzo secolo fa. Il mio nome è Giovanni. Ma chi sia io mi riesce difficile comprendere. Oggi è l’ultimo giorno d’estate, giorno di equinozio questo 23 settembre, che ha portato cieli sereni sulla mia Valle; ora è sera, ed il vento comparso nel tardo pomeriggio si sta rafforzando. Guardo dalla terrazza di casa verso occidente; i giorni dell’estate hanno lentamente consumato quel patrimonio di luce che li faceva durare in eterno, complice l’ora legale. La sera tende ormai a prevalere velocemente sul pomeriggio, e mi pare che le ombre della notte calino con maggiore rapidità di prima. Tuttavia fa ancora caldo, ed anche dopo il tramonto fa piacere sedersi su una sedia sdraio, e gettare l’occhio verso il Rocciamelone, la montagna sacra della Valle di Susa. Così faccio anche adesso, e noto che la vetta è occultata dalle nubi, dunque il vento porterà maltempo dall’alta valle. Non so che ora sia, è ormai per me un vezzo non portare più l’orologio, da quando ho acquisito una dimensione diversa del tempo. Tuttavia non è difficile indovinare il momento; non ho ancora sentito i rintocchi del campanile del paese scandire otto colpi, ma ricordo distintamente un unico rintocco, quello della mezz’ora, mentre prima avevo distintamente contato sette battute. Dunque si corre verso le otto di sera.
Mi alzo dalla sedia, e stancamente mi avvicino al tavolo; osservo il bicchiere posato, un avanzo di Lemonsoda residua nel fondo. Non mi va di berlo, ho l’impressione che la bevanda sia ormai divenuta calda, ed abbia perso quel gusto frizzante che la rendeva appetibile. Mi accenderei una sigaretta, ma da quando ho smesso di fumare le rubo a chi capita, ed in questo momento sono solo. Il totem, quel sacro camino che fuoriesce dal pavimento del terrazzo, mi occulta alla vista l’Abbazia di San Michele della Chiusa; inutile fumaiolo, giacché nessuno cucina più arrosti nella sala di sotto, da almeno un decennio. Né altro, perché i fuochi sono spenti.
Ci passo intorno, ci giro a fianco; un attimo, un ricordo fugace, le mie bimbe che giocano a prendersi sul terrazzo, e poi la mano sull’inutile stele, “Libera tutti”.
Giovanni, dunque.
Tutto nel mio paese richiama al Medioevo, e l’Abbazia Benedettina che sovrasta il Pirchiriano ne è il suggello più eclatante; taluni dicono che abbia ispirato Umberto Eco per la stesura del suo romanzo più famoso, “Il Nome della Rosa”.
“Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”.
Se l’asserto fosse vero, la mia vita, e la storia di quest’estate, che ha cambiato tutto e niente, che mi ha visto valicare monti e solcare mari, che ha tracciato linee imperiose ed imposto percorsi da seguire, che ha segnato barriere nuove e demolito confini vecchi, si ridurrebbe al mio nome: Giovanni.
“Dono di Dio”, o “Misericordia di Dio”, tale il significato etimologico dello stesso; ma non mi sembra di essere stato un dono per nessuno, a cominciare da chi mi mise al mondo, e quanto alla Misericordia, lascio ai teologi il compito di disquisirne.
Se proprio dovessi scegliere, mi piacerebbe essere un giovanni qualunque, con la lettera g minuscola.
Hanno portato il mio nome maestri di fronte ai quali la mia pochezza si manifesta, fino quasi ad evidenziare la mia nullità di fondo.
Giovanni l’Evangelista, l’Aquila, colui che ha colto il “Logos” di Dio nell’incarnazione dell’Unigenito, che ha cantato con voce sublime nel quarto evangelo. E poco importa se l’esegesi moderna esclude che un povero pescatore di Galilea potesse esprimersi correttamente in greco, sì da scriverne un sacro annuncio. Varie e differenti sono le strade, ché già il Paraclito conosce il fatto suo. Non si deve indagare. A me piace vedere Giovanni che reclina la testa sul petto del Cristo, sublime abbandono; ed ancora lo vedo in Efeso, vecchio ed ammirato sapiente, scorgere con malcelato stupore la decadenza dei tempi, ed anticipare il ritorno glorioso del Suo Maestro, di cui ne dà Rivelazione nell’ultimo libro che fu incluso nella scrittura.
Giovanni Evangelista, che non morì martire, e che attese con Maria la fine dei giorni terreni, prescritta per ogni uomo.
Oppure Giovanni, il Battista, cugino di Gesù, colui che esultò di gioia nel grembo materno, all’udire il saluto di Maria che recava visita ad Elisabetta, sua madre.
Non gli valsero carismi superiori e semplicità di vita; la sua testa mozzata, un lieve filo rosso di sangue a segnare le carni slabbrate, un riflesso sull’argento lucido del vassoio, per far godere una donna, in un gioco sadico dettato da una stanca commediante.
Ma Giovanni fu anche papa Roncalli, il ventitreesimo nella storia dei pontefici; “Pastor et Nauta”, pastore di anime e marinaio di Venezia, alla cui diocesi presiedeva con grande senso di giustizia ed umanità. Giovanni il buono, che iniziò la riforma della Chiesa, ed al quale fu negato il vederla compiuta; colui che amava i bambini, e li avvolgeva tutti nella carezza benevola di un nonno affettuoso.
E poi imperatori di Bisanzio e sovrani di paesi dalle lingue slave, archimandriti delle Chiese d’Oriente e santi della Romana Chiesa, capitani di ventura dalle Bande Nere e signori del Rinascimento; ed ancora contadini senza istruzione e mercanti di un’epoca segnata dal cambiamento e dalla fine dell’Evo di Mezzo, ed ancora tanti, tanti altri.
Oggi il loro nome rimane, talora nei libri di storia, talora in memorie private; più spesso, nelle tombe dei piccoli cimiteri di provincia, spesso spoglie, a testimonianza di un ricordo ormai spento, prima sopito e poi soffocato dall’incedere degli anni.
Malgrado tutto, io sono Giovanni.
E nemmeno un giovanni qualunque, secondo il mio desiderio; perché, per alcune persone che hanno intrecciato le loro vite con la mia, io sono “quel” Giovanni.
Per mia moglie, che ho sposato vent’anni fa, e dopo un periodo così lungo anche i Moschettieri del Re erano vecchi e stanchi, secondo il loro mentore Dumas.
Per la mia amante, che ha creduto in me a dispetto dei radi capelli che porto ancora sul mio capo, o del pizzo così interamente bianco che insiste sul mio mento e mi conferisce un’aria decrepita.
Per le mie figlie, che ho visto crescere e mutare, schiudersi alla vita e divenire donne, pronte a commettere sbagli ed a scrivere nuove pagine nel libro misterioso dell’umanità.
Per tutti quelli che hanno avuto rapporti specifici ed in quanto tali speciali con me, per ragioni di lavoro o di studio, di politica o di religione, di tempo libero o di associazionismo, che ho incontrato in viaggi od a casa, od in mille tempi ed in mille modi diversi, interferendo nelle loro vite, talora migliorandole, talora rendendole nettamente peggiori, od infine passando sui loro visi come un refolo di vento, ininfluente e presto dimenticato.
Giovanni, e già dal mio terrazzo vedo che le ombre della notte hanno preso il sopravvento; il cielo eccessivamente illuminato del paese copre milioni di stelle, tuttavia il Gran Carro si mostra evidente nella sua nitidezza, lievemente a lato della volta celeste.
Non ho voglia di andare a dormire; mi va di ripensare a quest’estate. Che con oggi muore. Che ha significato tanto, ma in fondo è ben poca cosa. Vorrei capire, nel tempo che ancora rimane prima che la Parca Thanatos recida il filo della mia vita, vorrei capire ancora il senso di quest’ultimo tempo di calore opprimente, di luce che abbaglia e non si stempera. Un paio d’ore, e la Metà della Notte sancirà l’entrata dell’Autunno, e vorrei come Faust dire all’attimo “Fermati dunque, sei bello!”, ma nessun Mefistofele mi ascolta.
Solo il ricordo si fa strada in me, e lentamente la matassa si dipana.
Ed ora vedo nitidamente i contorni della storia. Di questa strana storia, che ebbe inizio intorno alla metà di Giugno.
Primo Giorno d’Estate, all’Abbazia della Sacra di San Michele
Era il ventuno di giugno dell’anno 2008, e la data cadeva nel giorno di Sabato.
Tutto parlava d’estate in Valle di Susa; la Primavera era stata capricciosa, come d’uso, con l’alternarsi di periodi di tempo stabile e soleggiato, dalla temperatura mite, a scroscianti piogge che battevano il terreno incessantemente, pesantemente, metodicamente, fino a provocare un senso di ripulsa anche nei soggetti manifestamente non meteoropatici.
Un paio di settimane prima un diluvio di circa tre giorni era sembrato annunciare la riedizione dell’evento alluvionale, che aveva quasi ucciso il territorio all’alba del nuovo millennio.
Come di consueto, con una moltitudine di altri cittadini, mi affacciavo alla Dora, maestosa nella sua piena, e titubante mi domandavo se questa volta gli argini sarebbero riusciti a contenere la sua furia. Alberi dal grande tronco venivano trascinati dalla corrente, e parevano barchette di carta leggere, trasportate ora qui ora lì con totale noncuranza, mentre un raggio di sole filtrato da una momentanea spaccatura delle nubi, subito richiusa, rifletteva sulle masse scure in balia delle acque impazzite. I pilastri del vecchio ponte sul fiume intercettavano una quantità considerevole di legname, e provocavano una diga involontaria foriera di pessimi presagi per gli abitanti della zona. Tutti erano mobilitati, tecnici comunali e protezione civile, tutta la macchina di salvaguardia dal disastro girava a pieni giri, ma nessuno avrebbe potuto garantire un esito positivo alla vicenda.
Serviva fortuna, ed il caso benigno non abbandonò il paese; quando le acque erano prossime a tracimare, l’ondata di piena decrebbe ed il grande fiume decise di rimanere nel suo letto, a beneficio dell’intera cittadinanza.
Lo spavento transitò veloce nella percezione degli abitanti della Valle, ed il sollievo che ne seguì seppellì definitivamente la stagione primaverile nelle menti e nei cuori, oltre che nella natura.
Il sole cominciò a bruciare, il caldo si fece sentire. I torrenti rapidamente seccarono, così come repentinamente erano cresciuti fino a divenire un pericolo ed una minaccia per i terreni vicini. Il cielo, prima ingombro di tempesta al punto da essere totalmente chiuso, poi puntinato di nubi che si divertivano a disegnare strane e mostruose forme geometriche, tali da evocare animali da bestiari, divenne terso, e l’azzurro del pomeriggio si volgeva a sera in un blu intenso, con riflessi d’indaco. Le fioriture iniziarono a scemare, ad esplodere solo a quote maggiormente elevate, in montagna, mentre legioni di insetti, non più decimate dal precedente maltempo, s’impossessavano del territorio e si apprestavano a portare come sempre noia, fastidio, irritazione.
La gente iniziava a sognare il periodo di ferie, ed il mare era un miraggio, un’attrattiva per i più.
Le ante degli armadi si erano definitamene chiuse davanti a soprabiti e tailleurs; le donne avevano abbandonato le calze ed infilavano i piedi dalle dita laccate di rosso in sandali e sabots, mentre le più audaci, o forse le più giovani, incominciavano a girare con le infradito.
Forse anche gli amori sbocciavamo, o giungevano a compimento; nell’aria tiepida della sera, sotto cieli stellati che promettevano la Buona Fortuna, le auto si fermavano presso la montagna, ed i fugaci amplessi venivano consumati, in maniera diversa secondo le opzioni di ciascuno.
Tutta la terra aveva dimenticato l’inquietudine della primavera; ora l’estate andava a cominciare nella stabilità e nella pienezza. L’opulenza dei campi aveva raggiunto il massimo splendore, ed il grano era in procinto di essere tagliato.
Quando il fatidico 21 giugno si presentò alle porte, tutti erano pronti a godere della bella stagione, ed il calore provocava un senso di lieto stordimento, una vertigine alla quale abbandonarsi, per cadere nel vuoto e finire dolcemente frenati da un covone di fieno.
Occorreva solo un evento formale, per dare inizio alle danze; ed ancora una volta fu la millenaria Abbazia di San Michele della Chiusa a scandire l’evento.
Pubblicizzata nel sito dei Padri Rosminiani, e trasmesso con un passa parola assolutamente efficiente, la cerimonia tanto attesa ed auspicata, negli ambienti degli iniziati, fu resa manifesta ai molti: in quella sera si sarebbe tenuta la solenne prima rappresentazione della “Missa in Dedicatione Sancti Michaeli Arcangeli”, composta dal Maestro Enrico Euron, e suonata e cantata dai musici e coristi dell’Accademia Stefano Tempia.
Dunque un evento epocale nella storia della musica contemporanea; ed una prima alla quale per nessuna ragione al mondo avrei potuto rinunciare.
D’altronde, nulla ostava al mio progetto; per cui, presa la vettura di servizio, dopo aver consumato una frugale cena, m’indirizzai per i sentieri conosciuti che attraversavano il bosco dei Bertassi, costeggiando in seguito il Lago Grande di Avigliana, specchio d’acqua calmo ed argentato nella sera; svoltato in direzione di Giaveno, iniziai a prendere quota. Ora, lasciata la direttiva principale mi dirigevo deciso verso l’Abbazia, e la strada era tutto un susseguirsi di curve dal corto raggio e dalla pessima visibilità; dai lunghi tratti percorsi a mezza costa vedevo di sfuggita l’estendersi in basso della valle, in un tripudio di luci.
I borghi di Mortera e di San Pietro furono di compagnia nel tragitto che si susseguiva nel silenzio; e finalmente il grande complesso abbaziale mi si parò dinnanzi. Ancora poca strada, e finalmente potei abbandonare la vettura, lasciata a sostare in un buco rubato ad un posteggio già strapieno.
Ora mi confondevo con la fiumana che ordinata sciamava, attratta dalla luce del corpo principale della Chiesa, e diretta da un rilevante numero di volontari, discreti e molto attivi. Più avanzavo, nella salita dal gradiente moderato, più mi addensavo con la moltitudine, entro la quale alcuni iniziavano a faticare ed a respirare affannosamente, maledicendo il lungo percorso di avvicinamento. Ma i più erano come affascinati dalle strisce illuminate della sottostante pianura, e seguivano con gli occhi i mille intrecci geometrici, le vie di fuga e quelle di ritorno, le curve che partivano da chissà dove e si avvinghiavano su loro stesse, per toccare punti di tangenza comuni ad altre strade, ad altre vie, ad altri percorsi.
Il gruppo che ingrossava fu frenato ed accodato in prossimità di un passaggio obbligato, sotto la torre di guardia. Poi l’umanità convenuta si allargò, in presenza del primo ed ampio ordine di scale; infine tutti sostammo nei pressi della foresteria, dove le biglietterie si apprestavano a fronteggiare la richiesta degli utenti, pervenuti in misura assolutamente superiore alle aspettative dei promotori dell’iniziativa musicale.
Tenera si era fatta la notte, calda, accogliente; in mezzo a quell’umanità straripante distinguevo i sorrisi degli amanti, gli ammiccamenti reciproci, lo sfiorarsi fuggevolmente il dorso della mano, mentre scagliati dagli occhi gli sguardi irradiavano ora il viso dell’amato, ora l’Abbazia sfolgorante di luci, ora la valle sottostante, coi suoi corridoi luminosi strettamente intrecciati.
Sopra la biglietteria, a ridosso di un muro del monastero e piantato saldamente su di uno spuntone di roccia, imperava “Lui”. Effigie immane di bronzo, Michele veniva raffigurato in un’iconografia del tutto nuova. Non brandiva più la spada, che giaceva conficcata nella roccia, segno che il combattimento col Maligno era giunto alla sua conclusione. Dispiegata un’ala, ripiegata l’altra, il Capo delle Milizie Celesti indicava la via dell’ascesa. E dunque c’incamminammo seguendo la mistica indicazione, e varcammo il portone d’ingresso. Dopo due brevi rampe, lo scalone dei morti ci si parò innanzi; ora la folla saliva in disordine, si sbandava, qualche vecchio si teneva al mancorrente di ferro, qualcuno rischiava di mettere un piede in fallo e scivolare giù. Ma l’antagonista di Michele ancora una volta non prevalse; nessuno precipitò sulla rampa, nessun elisoccorso fu costretto a puntare sul Pirchiriano per recuperare qualche morente.
Il Portale dello Zodiaco mi ricordò il mio segno celeste: “Pisces”.
Due pesci, in opposizione ed intima armonia tra loro, rappresentavano gli aspetti contraddittori della mia vita, che nell’estate di fuoco raggiungeva il compimento dell’età matura. Oltre, vedevo solo la temuta ed aborrita vecchiaia. E sullo sfondo, la Morte, inevitabile con la sua falce. Nei momenti di tristezza già me la sentivo sulla spalla, poi la nera immagine svaniva in un sorriso, ed il tempo pareva nuovamente farsi eterno. Ancora non conoscevo tutto quello che avrebbe portato con sé l’estate: il risveglio dei sensi, il gustare sapori dimenticati, il vivere emozioni da tempo sopite, confinate nella nebbia del ricordo. Ancora non sapevo di Te, la mia speranza nell’inverno nevoso che ci aveva visto scendere insieme le incantate piste da sci del Monginevro; ancora non credevo che mi sarebbe stato possibile innamorarmi di nuovo, ancora una volta, un’ultima volta.
Perché ti amo, sai. È banale pensare che avresti potuto essere con me, mano nella mano, alla festa d’inizio estate alla quale mi apprestavo a partecipare. Non c’eri; pure il pesce in pietra già sapeva, nella sua immota saggezza, e nulla mi comunicava. Così, andai avanti.
Ora, sotto gli archi di De Andrade, iniziavo a vedere volti conosciuti, alcuni amici, altri no.
Come quelli del politico locale che si accompagnava alla sua nuova donna; questa, in maniera assolutamente sconsiderata, si era vestita da sera con un lungo vestito scuro cadente sui piedi, infilati in un paio di scarpe decolleté dal tacco allucinante. E questo mentre sfilavano ragazze e signore in jeans e scarpe da tennis; e poi barbe d’intellettuali, facce di professori di scuola, gente sulla quale leggevi sul viso le tracce di un impegno sociale, coerentemente portato innanzi ma non privo di ostentazione.
Il Senatore di Pinerolo si accompagnava alla moglie, entrambi belli, radiosi, volti e vite baciate dalla Fortuna; si faceva largo fendendo la folla, che si ritirava al suo passaggio come l’onda del Mar Rosso ripiegandosi aveva lasciato sgombro il passaggio agli israeliti. Non si capiva se questo accadeva per rispetto o repulsione; ma tutto in quella notte appariva improbabile e possibile al tempo stesso.
In breve le genti furono accomodate ai loro posti, mentre lo sguardo spaziava intorno alla Chiesa ormai piena in ogni ordine di posto. Quasi d’istinto il silenzio prese il sopravvento, ed un uomo piccolo di statura, il Rettore della Sacra, iniziò con un discorso a tratti informale, dando alcune linee indicatrici sull’evento che andava a compiersi.
Poi, dopo un primo applauso liberatorio, tutto tacque; le luci si abbassarono, e la zona absidale, intorno all’altar maggiore, si popolò quasi d’improvviso di musici e coristi, gli uni seduti davanti al tabernacolo coi loro strumenti, gli altri indietro, disposti a semicerchio come i monaci, in piedi, veste lunga le donne, abito scuro gli uomini, col libro rosso delle parti stretti nelle mani.
Il maestro dette la nota col diapason, e la grande Messa di Euron incominciò.
Dapprima un Ouverture, dai classici temi che riecheggiavano arie di Sibelius; quindi l’Opera si sviluppò secondo i momenti del graduale romano.
Un’atmosfera divina pareva spargersi nell’aria della millenaria chiesa, e quelle mura che avevano udito i monaci intonare in gregoriano i canti e gli eventi religiosi di stagioni lontane, proprie dell’alto medioevo, nuovamente venivano riempite di arie sacre, melodiche, profondamente sentite.
Le musiche celtiche, di cui il compositore Euron era studioso ed ammiratore, fuoriuscivano e si mischiavano con temi bassi, più consoni all’espressione religiosa. Il mix di armonie mi faceva pregustare quello che ebbi in seguito la fortuna di dire e testimoniare al compositore stesso: in quella magica notte veniva esternata una pagina, destinata a rimanere nella storia della musica.
Il pubblico reagiva bene, ma in maniera differente relativamente alle proprie emozioni; alcuni erano ammirati, altri estasiati, altri ancora a fatica nascondevano noia e sbadigli; sguardi venivano scambiati, quasi che l’incertezza delle percezioni dovesse trovare una rassicurazione nel parere del vicino di banco. Qualche coppia giovane, s’intuiva, era persa nel proprio sentimento di vicendevole amore, qualcuno inveiva in cuor suo contro il Senatore di Pinerolo, altri pensavano ai fatti loro.
L’opera si concluse con un trionfo, ed un atteso bis; un idiota suggerì alla ragazza che sedeva al suo fianco di non spellarsi le mani nell’applaudire, altrimenti c’era il rischio che lo strazio continuasse nel tempo. In breve alla folla fu comandato di sciamare verso l’uscita superiore, impegnando un percorso circolare tangente in un punto alla Torre della Bell’Alda, a picco sull’abisso, che correva parallelo alla base della costruzione, marcando i confini tra la pietra ed il bosco, per poi riaffiorare quasi all’altezza del Sepolcro dei Monaci.
Fu giocoforza seguire il flusso; ma quando giunsi al Monumento Sepolcrale, sotto le stelle, mi scostai in breve dagli altri cuori che battevano, e dalle differenti vite che portavano a compimento il proprio destino.
Solo, guardavo ora l’Abbazia illuminata; il cielo mi sembrava promettere qualche cosa di particolare, qualche evento specifico che avrebbe avuto un sicuro riverbero sulla mia vita, ma non riuscivo ad intercettare il suggerimento. Solo, sapevo che sarebbe successo.
Non avendo la sfera di cristallo, altro non restava che andare a riposare; e così mi comandai di fare. Scesa la strada che univa l’Abbazia al piazzale sottostante, sfiorai un autobus che, già caricata la comitiva che aveva trasportato all’andata, s’incamminava ad intraprendere la strada del ritorno.
Raggiunsi la mia autovettura, vi salii sopra e, come i Magi, per altra strada feci ritorno al mio paese. Mi accolse la figura amica della mia casa, vi entrai e scoprii che tutti, nella mia famiglia, dormivano già.
Ottima cosa: mi unii al gruppo e feci altrettanto.
Monginevro
Sui monti di Francia, dal 6 al 13 luglio
Viene un tempo, nella vita, in cui fare chiarezza diviene un obbligo morale, un atto di giustizia nei confronti di noi stessi. E per lanciare lo sguardo introspettivo, occorre rifugiarsi nella Fortezza della Solitudine, così come faceva Superman. Ognuno di noi ha un proprio deserto, un orizzonte perduto nel quale affogare i pensieri dell’immediato, per riuscire a far riemergere le verità profonde inerenti alla propria persona. I luoghi sono diversi, non comparabili gli uni agli altri; solo oggi, Amore mio, mi hai portato nel tuo, presso quella canonica di Giaveno, dove le case finiscono e la campagna incomincia, per poi digradare in verdi colline, cui l’arco alpino fa da corona.
Ed io, che pure avevo bazzicato a lungo in quei luoghi, mai avrei potuto credere che esistesse una tale oasi di pace, rotta solo dal cammino degli uccellacci che stanchi di volare si divertono a misurare la lunghezza di un campo. Nessuno era presente nella zona, se non forse il prete ed il canonico, come testimoniava l’auto posteggiata vicino alla porta dell’edificio. Grazie a questi importuni ho potuto rubarti solo un bacio; altrimenti sarebbe stato per me giusto giacere in compagnia del tuo seno nudo, da me sfiorato con le dita della mano, e poi soffiato con l’alito della mia bocca, succhiato dalla mia lingua, fino a farti inturgidire il capezzolo ed a farti desiderare carezze più audaci, tali da farti tremare e desiderare il compimento dell’amplesso.
Ma non era quello che desideravo, anche se fossimo stati soli; no, tu parlavi, affabulatrice, e raccontavi di notti non dormite, trascorse sedute sul muretto che mostravi, a chiedere risposte sui problemi della tua vita, ed a ricevere conforto dal sussurro del vento.
Ed io, infelice, pensavo a te sola; chissà dov’ero in quei momenti, da quali correnti venivo trascinato, quali punti della retta del mio percorso stavo impegnando, cosa facevo… ancora non ti conoscevo, ancora non ti amavo, ancora eri per me null’altro che un’ombra sperata.
Ma oggi è un giorno d’autunno, anche se pare estate; e dunque s’impone tornare al ricordo.
Avevo maturato il desiderio di solitudini; scelsi perciò accuratamente un periodo di ferie, in maniera che si accavallasse inesorabilmente coi problemi della mia famiglia. Decisi quindi che avrei trascorso una settimana, la prima completa del mese di luglio, in Monginevro, nella mia casa, scegliendo di andare per monti e per valli.
L’estate si avviava alla sua piena maturità, quando salimmo tutti insieme al monte, io ed i miei familiari. Loro però sarebbero ridiscesi la domenica, abbandonandomi ai miei fantasmi; ed io avrei cercato di sopravvivere, salendo, salendo, salendo fino a toccare il cielo con un dito.
La frenesia della vacanza portava con sé la noia dei preparativi; ancora una volta muoversi in branco mostrava tutti i suoi limiti.
Valigie inutili per il brevissimo soggiorno dei miei familiari, viveri che sarebbero bastati a sfamare un intero reggimento di assaltatori, dotazioni informatiche che avrebbero ridicolizzato quelle di un esperto agente del Mossad; tutta questa fiera dell’inutile, veniva da me sopportata con minor fastidio, perché la certezza che alla fine mi sarei trovato solo, con me stesso, con le mie paure, con le mie speranze mi dava sicurezza.
Infine, in una notte scossa da refoli di vento freddo, giungemmo all’abitazione montana.
Sceso da cavallo, come uno Sherpa nepalese portai il vettovagliamento ed il kit per la sopravvivenza di fronte alla porta di casa, che cigolando sinistramente si aprì.
La visione degli interni apparsa allo sguardo pareva ferma ad un tempo della primavera passata, come in una vecchia fotografia; ora, tutto sarebbe sorprendentemente tornato a vivere.
Ma questa era storia di domani; già la giornata presente andava a spirare, e le palpebre si chiudevano, in attesa di vivere una serie d’intriganti eventi. Almeno, tale era il mio sentire.
Poi la porta fu chiusa.
Salendo il Janus
Night on the Bare Mountain; una notte sul Monte Calvario. C’era tristezza nell’ascensione che compivo con mia moglie, e la montagna stessa era divenuta fredda, ostile, fieramente avversa. Quella che era parsa una giornata serena andava assumendo tinte fosche; il cielo si era riempito di nubi di vento ed in effetti folate di aria ci venivano incontro, con l’intenzione di rigettarci indietro. Non so perché mia moglie avesse deciso di salire; forse per fuggire dalla noia di un giorno vuoto, forse per non sentirsi assillata dalle richieste continue ed insistenti delle figlie, forse per rimuginare nella sua mente gli strani pensieri che da tempo la turbavano, segreti a me mai rivelati eppure così presenti nel quotidiano, da condizionarlo in maniera significativa.
La partenza era stata nevrotica; frenetico il prepararsi, rapido il varcare la soglia di casa, veloce il discendere gli stretti tornanti che portavano dalla zona alta del paese alla route nationale; attraversato lo stradone avevamo raggiunto la zona piscina, e di lì iniziato l’ascesa.
All’inizio il passo di lei era eccessivamente veloce, e ricordo tutta la fatica sostenuta per tenerle dietro, certo com’ero che se mi fossi distaccato non mi avrebbe aspettato; poi, gradualmente, avevo preso l’andatura del montanaro, e la fatica più non spezzava le mie gambe, anzi quasi mi accorsi di non sudare più. Ora la schiena di lei si riavvicinava, e presto le fui al fianco; uno sguardo, e notai come avesse bruciato troppe energie e troppo in fretta. Adesso faticava, e nel suo volto prevaleva un atteggiamento improntato allo sconcerto: non aveva previsto che il suo limite si sarebbe manifestato all’improvviso, od almeno, non così in fretta.
Pure, non era il fisico affaticato che reclamava; ben altri fantasmi agitavano il suo volto, altre paure, altre storie che mai avrebbe raccontato a me, che formalmente ero pur sempre il suo compagno nella vita… Formalmente, perché le nostre strade si erano andate divaricando come una forbice aperta, ed ogni passo ulteriore che compivamo sanciva il nostro inevitabile allontanamento.
Forse per questo l’escursione era muta; nessuna comunicazione possibile interveniva tra noi se non il patto segreto di violare la montagna, intesa come sfida con se stessi.
Io la guardavo, con distacco; vedevo il fisico asciutto, integro, che ancora la sorreggeva, elevarsi ad ogni passo, mentre gocce di sudore colavano dalle tempie e striavano il viso. Se ne accorse, si fermò e dallo zaino estrasse un fazzoletto variopinto, che si annodò sulla fronte a mo’ di bandana; ora si beava di apparire come un comandante della fratellanza piratesca, e questo trucco d’attrice le dette forza, sì che sembrò nuovamente staccarmi, ma fu solo un attimo ed in breve la ripresi.
Una marmotta lanciò il suo fischio, e quasi contemporaneamente una folata di vento vorticò intorno alle nostre orecchie; ora una nube di grandi proporzioni si accingeva a coprire il sole, e presto la folgore si sarebbe scagliata contro la terra, e forse contro di noi, che orgogliosamente scalavamo l’Olimpo per portar guerra ai Titani.
Mi chiedevo quali fossero i suoi pensieri; benché fossi intuitivo, e spesso riuscissi ad indovinare ciò che si cela nell’animo umano, mi pareva che una corazza nera ed impenetrabile schermasse i suoi pensieri, che restavano indecifrabili ad ogni lettura.
Sapevo un nome, un nome di donna; ma come la cavallina storna di Pascoli non poteva rivelare i segreti dell’assassino, così la montagna era muta testimone del tormento interiore di lei, e nulla mi trasmetteva, ché tutto teneva celato per sé.
Avrei voluto essere d’aiuto, lenire il dolore; invece ero solo un estraneo, al quale chiedere al limite la borraccia per bere.
Nella salita incontrammo viandanti che praticavano il sentiero in senso opposto al nostro; già scendevano, pur non essendo ancora la mattinata trascorsa, ed il mezzogiorno lontano ancora un’ora almeno. Calavano dai picchi, con ampie giravolte, seguendo la strada; ed ai miei occhi parevano le coorti romane a guardia dell’esecuzione sul Monte Calvo, appena fuori Gerusalemme, mentre si disperdevano sotto i colpi dell’uragano e dell’eclissi imminente, dubbiosi in cuor loro sul misfatto che avevano compiuto.
In alto, la stazione terminale della seggiovia girava i sedili pensili con un anello e ne invertiva il percorso; i pali sembravano le croci, o le forche a cui appendere i condannati, che sguaiati si dimenavano sotto i colpi del vento, agitando le gambe nell’osceno balletto finale.
Avrei voluto fermare il cammino, e ridiscendere verso il porto sicuro della casa che ci attendeva a valle; invece no, lei aveva ripreso ad ascendere con cattiveria, con accanimento.
Non ho mai saputo quali rivincite si stessero consumando nel suo spirito; forse, a sera, la sua voce avrebbe trasmesso al telefono cellulare le gesta dell’impresa, e chi di dovere sarebbe stato umiliato e nudo di fronte a tale manifestazione di potenza.
Infine la ripresi, all’altezza delle caserme del Gondran, e più non mi sfuggì; disfatta mi seguiva, ed il movimento pareva solo più il residuo di un moto inerziale, non governato dalla mente.
Quando si rese conto che inesorabilmente la distaccavo, rabbiosa mi urlò contro di andarmene e di non aspettarla; ed anche questa era una metafora della vita, della sfiducia che ottenebrava un ventennio di quotidiana frequentazione, che una volta era stato nel segno dell’amore, per poi ripiegare in rispetto ed abitudine prima, e nell’indifferenza dopo.
Al contrario, l’attesi: e come un dolce veleno di rivincita il mio messaggio consisteva nel renderle manifesta la sua debolezza, la sua fragilità, il bisogno di un aiuto che la mente orgogliosa rifiutava.
Il sole era ricomparso, respingendo la nube che l’aveva ingabbiato; ora impegnavamo l’ultima salita, gettando con lo scarpone i ciottoli a lato, e tentavamo invano di vedere il portone carraio del Forte Janus, che ci avrebbe segnalato la fine della fatica.
Una strettissima curva ci consentì di prendere quota un’ultima volta, e svelò ai nostri occhi quello che l’immaginazione aveva visualizzato con grande anticipo: Forte Janus era lì, fermo, di fronte a noi. Ma solo i fantasmi dei guerrieri di tanti, troppi anni fa si aggiravano fra le maestose rovine; pareva un avamposto abbandonato dalla Légion Etrangère, a fronteggiare un deserto di pietre, in attesa di un nemico che più non sarebbe giunto, scendendo dalle italiche cenge a portare morte, sconfitta, distruzione. Solo il silenzio militare, suonato con la tromba dallo spettro di un Cacciatore delle Alpi, riempiva con le sue note il grido selvaggio della natura; ed a noi, stanchi ed affamati, non rimaneva che sostare, ed elevare al cielo una preghiera.
Forse neppure gli dei avevano desiderio d’ascoltarci quel giorno e tacquero ostili.
Tra di noi la freddezza del cuore si frammischiava all’asperità della roccia; entrambi giravamo in cerchio, osservando i resti dei passati bivacchi, fuochi consumati sul limitare di un prato che scendeva improvviso a precipizio e si trasforma in dirupo. Ci pareva d’udire canti improvvisati di giovani attorno alla piccola fiamma, ed una chitarra che impostava un giro di note, attaccando il refrain di una ballata triste.
Forse era il ritornello della “Locomotiva”, di Guccini; o forse questa volta sarà stato l’urlo del vento ad ergersi contro l’ingiustizia, ed a gonfiare d’aria un vessillo che non vuole volare, alto, come dovrebbe.
Ma i giovani sono scesi, le corde della chitarra hanno smesso di vibrare, il fuoco allegro e vitale si è consumato e trasformato in cenere; nulla rimane, se non i nostri passi che disegnano per terra insignificanti tracciati, e si aggirano curiosi nel ricordo della festa che si è spenta.
Ti guardo in viso, pari rasserenata; adempi con equilibrio i banali passaggi che compie eternamente l’escursionista, svuoti lo zaino, consumi rapidamente un panino, attingi un po’ d’acqua dalla borraccia ancora fresca ed ingurgiti il liquido nella gola, bevendo avidamente.
Per un attimo riponi gli occhiali da sole in una tasca, e ti spalmi di crema abbronzante il viso; ma subito torni ad inforcare le lenti affumicate, e mi neghi per sempre uno sguardo.
Indignata osservi con odio il display del cellulare: non hai campo, invano pensavi di rincorrere un numero telefonico, qual numero telefonico, e di gridare rabbia e gioia, propositi di rottura e desideri di rappacificazione.
Sei sola, ma non è vero. Ci sono io. Forse neppure mi distingui da una pietra scheggiata del forte, da una trave del tetto scoperchiato lasciata a marcire fra le intemperie. Forse più reale di me è quello stelo d’erba che resiste al calpestio del turista, e che sfrontato fa mostra di sé nello spazio antistante una casamatta. Forse più reali di me sono il sole, il cielo, il vento, le cime degli altri monti che dalla nostra postazione osserviamo vicini, sì che ci pare che quasi potremmo toccarle tutte ed avvolgerle in un abbraccio, se solo lo volessimo. Più reale di me il moscone che ronza intorno al tuo viso, e tu che lo scacci con una manata, indispettita; più reale di me la pietra aspra e dura e fredda, mai quanto il tuo cuore.
Io esisto; per te non più, ma per me stesso ancora.
E mi accorgo di non esser più capace di amare; freddo come una componente montana mi aggiro nell’erba, in cerca di un fiore celeste da abbattere con la mia mano violenta, foriera di sventura; ecco che passo, come passa l’uragano e scarica la sua violenza sul mondo.
Momenti, poi tutto riprende, sempre uguale, sempre monotono; ed altri fiori celesti sbocciano, né mi ero illuso che la mia rabbia potesse gettare nel ghiaccio eterno il magico reame di Narnia.
Passa la morte, passa la rovina, e poi torna il sereno.
Sento che mi domandi qualcosa; e le mie orecchie sono sorprese dal suono della tua voce, e stentano a credere che tu possa rivolgerti a me, che sono l’amico sconosciuto, il testimone silenzioso, il partner discreto di una parte importante della tua vita, che giace forse dimenticata ma resta viva dentro di te, nelle profondità di uno spirito che non può rimuovere nulla, ma solo occultare, preservare, salvaguardare il vissuto di ieri dalla furia del presente, in attesa della bonaccia di domani.
Mi chiedi, ed io sento parole ma non afferro i concetti.
Per un attimo è beatitudine sentire il tono della tua voce, ora freddo ma non in preda alla collera, che con fare inquisitorio pone insistente un’istanza qualunque; e quasi vorrei che il monologo continuasse, senza risposta, ma solo per darmi la vita, l’esistenza, la realtà di un momento che fugge e non vorrebbe essere dimenticato.
Adesso vorrei risponderti, ma non trovo le parole; ti guardo, e vorrei essere benevolo, ma il mio tardare ti ripiomba nell’ira più cupa, e già mi volti le spalle, né t’interessa più sapere la risposta al quesito che avevi posto con meditata insistenza.
Il silenzio custodisce prezioso i miei pensieri; un breve cenno d’intesa, e la discesa ha inizio.
Pochi passi, e già il castello semidiruto, che ha subito le offese provenienti dai colpi dello Chaberton, l’imprendibile fortezza, è alle nostre spalle; più non risuonano i secchi comandi degli ufficiali, più non si vedono gli “Chasseurs des Alpes”, i mitici Diavoli Blu, intenti ad organizzare la difesa ed a predisporre il contrattacco.
Tutto è sfumato, nella nebbia del tempo che avvolge dolci rimembranze; e dieci minuti fa equivalgono a mezzo secolo, entrambi i tempi sono passati, calati nell’indistinto e destinati ad un vago sentire, finché duri la memoria.
Il ricordo rimbalza a catena per le balze dei monti, e ripropone l’affetto di un tempo felice; quando ascendere era gioia, ed ogni goccia di sudore impreziosiva i nostri visi disfatti dalla fatica, ma ravvivati da un sorriso malcelato.
“Tanto valeva, parlare chiaro già da allora, quando tutto era da fare, e tu non eri importante… Ma siamo qui… A Modena, sai…”; parole intrise di malinconia, tratte da una canzone di Antonello Venditti.
Noi eravamo lì, in cima ad un monte intitolato a Giano Bifronte; una metafora della vita, un ricordare al viandante che la verità è sempre duplice, o plurima addirittura, e non facilmente indagabile.
Come in una commedia di Pirandello discendevamo dal monte, e nessuno dei due poteva veramente dire di conoscere l’altro; ciò non di meno ciascuno di noi sapeva fino nei minimi dettagli le abitudini del compagno. Era una conoscenza senz’anima, un sapere che si nutriva d’inerzia; come i passi discendevano l’erto sentiero per automatismo, quasi senza guardare dove lo scarpone si posava, incurante di schiacciare ed annullare la vita di qualche banale insetto, che aveva avuto la mala fortuna di trovarsi sul percorso a lui fatale.
Il mio sguardo era talvolta rivolto al cielo, poi tornava a spaziare per le vaste praterie che insistevano sulla conca, e terminavano nello specchio d’acqua blu del lago del “Des Anges”.
Avrei desiderato che una spada sorgesse dal limpido specchio, sorretta nell’elsa dalla mano fatata di una donna, di una dea, e mi fosse recata in dono; o forse sarebbe bastato rispecchiarsi nell’acqua, ammirando come Narciso il proprio volto, fino allo sciogliersi di questo nel fuoco eterno che brucia, e che guarnisce prezioso il tetro reame di Mordor.
E cosa avrei mai chiesto all’Occhio Magico? Forse, Libertà?
Libertà da cosa? Dalla discesa dell’aspra montagna, per ritrovarsi altrove… lontano… soli, od in differente compagnia…
Magari a Milano, con le guglie del Duomo che proiettano la loro ombra sulla strada, mentre sto per imboccare corso Vittorio Emanuele in direzione di piazza San Babila.
Negozi, il buttafuori di colore guarda come un pitbull arrabbiato la zingarella dall’abito variopinto, coi piedi nudi e sporchi in un paio di zoccoli usati, che cerca la preda a cui occultare con gioco di prestigio il portafoglio; e vicino transita un campione di umanità, il ragioniere nascosto dagli occhiali dalle lenti spesse che fugge dal luogo di lavoro, per rituffarsi in una realtà familiare altrettanto triste e disperata.
Ecco, scendo dal sentiero, ormai anche i forti del Gondran sono dietro la schiena, ed il secondo livello appare a tiro; ed io sono nuovamente estraneo a tutto ciò, e mi aggiro per corso di Porta Romana, ed ascolto il parlare concitato della studentessa di fronte alla panetteria, che racconta all’amica del tradimento del suo fidanzato.
Un manager grida al telefonino, quasi si ferma sulla banchina del tram, a cercare una presa fantasma per dar vita al suo personal computer, e chiudere la vitale relazione che non ha terminato in tempo…
Tempo, tempo che fugge via, assenza di tempo; cimiteri di corpi e di anime, luoghi di raccolta di carcasse destinate a putrefazione, o stazioni asettiche baciate da luci al neon, in attesa che il prezioso feretro spinto dal carrello sullo stretto binario venga convogliato nel forno crematorio, dove brucia, e brucerà… Brucerà per sempre!
Ricordo l’esorcismo al quale assistetti; chiese all’Entità il Sacerdote:
“E dimmi, nell’Inferno c’è il fuoco?”
Si udì una risata sarcastica, poi gli occhi della vittima posseduta lasciarono trasparire un terrore infinito;
“Oh sì… Sapessi… Quanto brucia… Ma lo saprai quanto prima…”
Così bruciava la discesa; e come un eroe omerico mi pareva di discendere agli inferi, e mi chiedevo se mai avrei trovato la forza di risalire.
Guardavo lei, e cercavo d’immaginare i suoi pensieri; pareva domata, il suo spirito inquieto era entrato in mistica comunione con la montagna, ed il silenzio era ora privo di astio, ma contrito, e quasi si volgeva in preghiera.
Lei sapeva, ed era triste per la sofferenza involontariamente inferta; in fondo recitava una parte, nel grande gioco della vita, ed era solo un’attrice, nemmeno di primo rango, che interloquiva con un comprimario, dalla vicenda umana e personale del tutto trascurabile.
Che poteva mai significare un raggio di amore di fronte all’implosione di una supernova?
Quale concezione antropocentrica si era mai affermata nella nostra cultura, per dare un’importanza smisurata alla pena dei piccoli cuori umani?
Non avvennero forse in passato avvenimenti epocali, che chiusero ere, per aprirne altre?
Noi non c’eravamo, ed il nostro amore era sentimento insignificante di fronte alla trasformazione del creato.
Il veloce passo ci aveva condotto alla stazione intermedia delle seggiovie; una piccola cengia chiudeva ancora la visuale del paese ai nostri occhi, ma veloce il ritorno prendeva consistenza.
Superata l’ultima asperità, scollinammo veloci; ora incrociavamo i verdi prati del Campo Golf, ed il complesso dei tre grandi edifici raggruppati a ridosso delle piste si parava di fronte a noi, e pareva segnalare il compimento della strada.
Veloci carrelli elettrici si spostavano tra le buche, trasportando golfisti; ecco, io avrei voluto essere il caddie del mio amore, ed a lei portare le mazze nella sacca, limitandomi a guardarne gli armoniosi movimenti, e nutrendomi della sua bellezza.
La luce era ancora nel pieno del suo vigore, ancorché stemperata dalle nubi che correvano qua e là per i sentieri del cielo; ma l’escursione volgeva al termine.
Infine, rientrammo in casa.
La cena fu consumata in famiglia, finalmente eravamo riuniti con le nostre figlie.
A sera c’immergemmo in un assurdo programma francese, denominato “Fort Boyard”; una specie di Giochi senza Frontiere, consumati un una fortezza circondata dall’Oceano Atlantico, dove curiosi e sinistri personaggi si aggiravano proponendo prove di forza e d’intelligenza ai concorrenti, che venivano atrocemente puniti quando non risolvevano gli enigmi, venendo rinchiusi nelle segrete sotterranee del castello.
Giganti e grassoni, ed un paio di nani accompagnavano i presentatori, che conducevano i membri di una squadra attraverso i passaggi del gioco; ed era pure un alternarsi di maghi, indovini, mangiafuoco ed arcani aderenti a sette massoniche.
Le prove superate incrementavano un monte premi, destinato alla beneficenza.
Se non si superava l’ultima prova si poteva “virtualmente” essere divorati dalle tigri che si aggiravano veramente nel cortile del forte: Fort Boyard, appunto.
Infine, ciascuno nella propria postazione notturna, ci accingemmo ad effettuare un breve sonno senza sogni.
Il mattino seguente la mia famiglia partì, lasciandomi solo.
Poche e brevi raccomandazioni, e già salutavo la vettura che si allontanava veloce verso il Piemonte.
Per me, tuttavia, la vacanza era appena iniziata.
Ancora non sapevo cosa avrebbe portato; forse niente, forse tutto, forse solo il trascorrere di cinque giorni che sarebbero presto sfumati, lasciando una breve tacca nel fucile della vita che trascorre, di concerto col tempo che passa e che danza intorno a noi.
Finché il gioco finisce.
[continua]


