
Discesa all'infernodiFrancesco Gambellini |
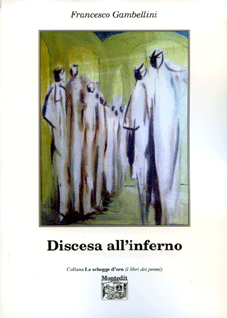
Collana "Le Schegge d'Oro" - I libri dei Premi - Narrativa
15x21 - pp. 246 - Euro 15,00
ISBN 978-88-6037-6602
Clicca qui per acquistare questo libro
Pubblicazione realizzata con il contributo de IL CLUB degli autori in quanto l’autore è finalista nel concorso letterario «J. Prévert» 2005
A quanti per ventura incontrati hanno fatto di me quello che sono, e che insieme con me, sebbene non direttamente, hanno scritto le storie di Dolcina, Clemente, Flavio, Giacinta, Nando… con l’augurio che sappiano riconoscersi in ciascuno di essi e salvarsi dal giudicare.
Discesa all'inferno
La satrapessa
Quando l’avevano messa in pensione, piena ancora dell’energia dei settant’anni, subì la cosa come un affronto.
Il fatto era che le figlie, quaranta-cinquantenni e ancora nubili, avevano tutte distillato, in tanti anni di pulzellaggio, l’esigenza d’una vita autonoma, d’una casa tutta loro da poter fare disfare e rifare a piacimento… E dunque per lei, vedova da qualche mese, non c’era più posto.
D’altro canto presero a circondarla di cure e di attenzioni sollevandola dai lavori pesanti prima, e da quelli minuti poi; sicché ebbe modo in breve di scoprire quel che di vantaggioso era possibile trarre dalla sua nuova condizione.
Pertanto vi s’acconciò prestamente trovando modo di querelarsi per il cibo poco cotto o mal distribuito, dopo tanti anni di proteste altrui. Che provassero quant’era difficile!
Esautorata così dalle cure familiari e dai lavori domestici, amava tuttavia aggirarsi accanto ai fornelli per spiare quel che vi si preparasse, e ogni tanto saggiarne il punto del sale e la cottura.
Per questo le fu preparata in soggiorno una poltrona a dir vero assai comoda, e le si ordinò di lì stare, per esser certo che in cucina, come altrove, troppi galli a cantar non fanno giorno.
Le sue perlustrazioni si fecero allora segrete e rapide come incursioni da cui ella tornava soddisfatta e sicura di quel che avrebbe potuto pretendere all’ora del desinare; e se una delle pietanze precedentemente scoperte non finiva nel suo piatto ne domandava ragione, sebbene non esplicitamente, fino a che una delle figlie non provvedeva. Quando poi in una delle sue scorrerie tra i tegami era colta in flagrante, si schermiva piagnucolando d’esser lì per un po’ d’acqua dal momento che il gran caldo le aveva proprio impastoiato la bocca.
E se le accuse venivano insistite, lei negava tutto con l’inzuccatura dei bambini.
Per vincere quella guerra non poterono infine far altro che affrettarsi a recarle in soggiorno i primi bocconi che giungevano a cottura e un assaggio di tutto ciò che si cucinava prima che i profumi arrivassero a tentarla.
Era l’andirivieni delle api operaie attorno all’ape regina: chi un dolce, chi una frittella, chi un frutto. Ed ella si lasciava nutrire abbandonandosi alle loro cure, solo proponendosi con un lagno strascicato se le pareva che per un poco venissero meno.
Un tempo quest’affaccendarsi senza sosta era stato per il consorte, che richiamava tutte a un servizio solerte, quando fiacco diveniva, con il tintinnare imperioso del cucchiaio sull’orlo d’un piatto o d’un bicchiere. Poi, alla sua morte, passato di mano il bastone del comando, ella ne aveva con prontezza raccolto l’eredità cominciando a imperversare; quietamente tuttavia, querelandosi quasi mendica ma consapevole d’essere oramai la padrona di tutto.
Poté così, sicura del suo potere, sistemarsi nella sua poltrona, e non s’accorse che dolci e assaggini, mentre le gonfiavano le guance, le svuotavano però le gambe d’ogni forza. Cosicché, quando un giorno le figlie non furono pronte ai suoi richiami e, per punirle, volle alzarsi e tornare in cucina, esse non la ressero più e l’abbandonarono a terra impotente.
In cinque accorsero in suo aiuto, e sputarono l’anima prima di riuscire a issarla in qualche modo. Col fiato mozzo, la sgridarono scaricando la loro paura… mentre ella con occhi di pianto guaiva confusamente il suo dispiacere e l’ematoma prontamente affiorato, ad ammansirle.
Sapeva ora, peraltro, di dipendere quasi al tutto dalle figlie; ma proprio per questo divenne ancora più esigente pretendendo che tutti parlassero in sua presenza in modo che niente le sfuggisse di quel che s’agitava in casa. Per ascoltare si piegava curiosamente in avanti porgendo alle voci l’orecchio più fine nell’udire.
Le figlie, d’altra parte, impaniate dalla pietà per l’impotenza di lei, stata per l’addietro sempre protagonista, raddoppiarono attenzioni e tenerezze affinché non patisse ella, per giunta, l’umiliazione di sentirsi abbandonata.
Realizzato che quella era la via, cominciò a lamentarsi apertamente per suscitarne la pietà e sommuoverle a servirla.
L’accompagnavano ora al bagno ad ogni richiesta, ed ella s’abbandonava pesando quanto più le era possibile al fine di marcare il loro stato servile. E se troppo se ne lamentavano (Se in giusta misura ne gongolava), le costringeva più volte allo stesso servizio, se non s’affrettavano bagnandosi, e pigolando poi di non essersi potuta trattenere; perché imparassero.
Così ella misurava i suoi nuovi poteri e riaffermava la sua autorità.
Aveva subito intuito, infatti, il vantaggio di restarsene in poltrona, purché la poltrona fosse il punto focale della vita familiare; di convergenza, in altre parole, di tutte le traiettorie, che ella governava dosando sapientemente astuzia e dolori.
Di modo che sebbene apparentemente ristretta sul suo seggio, era invece vasta e incombente in ogni angolo della casa; tanto che non sfuggiva ai suoi occhi pur offuscati il gesto più segreto, né ai suoi orecchi il bisbiglìo più lontano.
Quando infine giudicò che i tempi erano maturi (Perché le era parso di cogliere qualche stanchezza nelle sollecitudini filiali), s’inventò un impedimento misterioso alle mani che ora le obbedivano e ora no, costringendo così le poverette a uno zelo rinnovato nell’imboccarla perché non deperisse.
Nondimeno, per trascorrere di tempo, l’antica vigoria non più esercitata illanguidiva a poco a poco sfacendosi in uno con l’appesantirsi del corpo.
Ora infine dipendeva veramente dalle figlie che, in verità, le si dedicavano senza risparmio.
D’altro canto quella dedizione ammirevole e la pietà filiale universalmente note garantivano loro considerazione e compatimento generali.
S’era così creata, a ben vedere, una doppia dipendenza; cosicché come la gran madre aveva ora bisogno dei loro servizi, alla stessa maniera esse avevano urgenza dei suoi capricci a renderle meritevoli dell’ammirazione della gente che le considerava oramai le vestali di quel gran corpo. E tanto spazio esso occupava nella loro vita che mal sopportavano il pensiero del vuoto che le avrebbe lasciato morendo.
Per questo facevano a gara per conservarselo, contendendolo ferocemente alla morte. Una lotta senza speranza e, perciò appunto, commovente e patetica.
A morire ci aveva già pensato più d’una volta: quando, indispettita di trovarsi contro ogni suo volere in ospedale, era arrivata proprio ai confini, tanto che i medici per il buon nome del nosocomio s’affrettarono a rinviarla in famiglia, dove peraltro così prontamente rifiorì da far gridare al miracolo; o quando aveva strabuzzato gli occhi e s’era abbandonata riversa sul suo trionfo di guanciali… i medici l’avevano oramai già mollata, e le figlie erano tutte intorno in preghiera e la chiamavano a tratti per carpirle una reazione qualunque, ma ella inerte, con gli occhi chiusi e un piccolo rantolo che le tremava in certe vene del collo esangue, non le badava più.
Gridavano esse preghiere remote dimenticate da tempo e ora per prodigio riaffioranti, e, stanche oramai, la tentavano che lassù avrebbe cielo e schiere d’angioli a servire… Ma ella era impietrata.
“È fatta.” Disse un lontano parente.
“È il coma.” Giurarono altri.
Il prete accorse coi suoi lasciapassare per il cielo, e com’ella li subì senza niuna partecipazione, disse brevi parole di conforto e si defilò lestamente.
Le preghiere e il pianto s’eran ora chetati in una sorta di doglianza lamentosa: “Mi riconosci?” Domandavano invano senza saper più che sperare. “Dio mio! Fa che non soffra! Pensaci tu” Invocavano tuttavia.
Fu in quel preciso momento che, alfine soddisfatta, aprì un occhio, uno solo, le guardò drittamente, e con la voce ferma dei tempi migliori: “E ora – disse – datemi un caffè!”
Questa era la tempra; e molti erano certi oramai che la morte non avrebbe potuto prenderla che a tradimento… e forse non era astuta abbastanza.
Anche quell’ultima volta cominciò al modo di sempre: un grand’urlo e s’abbatté svuotata sui cuscini.
Accorsero ancora le figlie tutte che per niente al mondo volevano mancare l’appuntamento; la soddisfazione almeno di poter dire un giorno che fino all’ultimo…
Era insomma ricominciata la veglia, la trepida attesa che la volontà del Signore si compisse, e intanto si raddoppiavano le cure e le preghiere.
Ella, è naturale, si lasciava servire concedendosi alle carezze e alle premure continue, aprendo appena ogni tanto un occhio, ora l’uno ora l’altro, a controllare il loro zelo.
L’agonia fu lunghissima.
Io dico che, sospettando la ragione di quel loro attaccamento, era lucidamente determinata a fiaccarne la resistenza con la veglia estenuante che le imponeva.
Dopo dodici giorni e dodici notti ciondolavano infatti su sedie troppo scomode in feroce lotta con occhi che volevano chiudersi. Allora spianò il viso in rosea quiete e finse il sonno col respiro profondo e regolare dei tempi migliori. Cosicché, convinte, si consentirono esse un meritato riposo assopendosi brevemente.
Quando si destarono, nel colmo della notte, ella era già impietrita nel rigor della morte: glissando la ferrea sorveglianza delle figlie, ne aveva colto un momento di distrazione e, con un guizzo fulmineo, le aveva fregate tutte.
Fu un concorso di folla senza precedenti: zii, cugini, sconosciuti perfino, sfilando in condolente silenzio, vennero a renderle omaggio nel salone fastosamente addobbato come si conveniva a tanta morte. Poi sedevano intorno per l’ultima veglia, e le tapine in lutto ne badavano due-tre ciascheduna… Partivan coloro dalle lodi rituali della defunta (che inerme oramai non poteva più difendersene) e spulezzavano via in ogni direzione: dai loro morti alle stagioni che incombono al modo insolito di cucinare il coniglio.
Sola e in disparte, una delle orfane piangeva cheta; e se qualcuno le s’appressava a conforto, si querelava singhiozzando: “Non doveva morire! Non doveva proprio morire!”
Invano le facevano considerare che la defunta era oramai prossima ai cent’anni. Non potevano sapere, d’altra parte, che la meschina piangeva non tanto per quella morte, cui peraltro negli ultimi mesi s’era acconciata a rassegnarsi, quanto per tutto ciò ch’essa le sottraeva: lo stupore e il rispetto per quell’amore filiale fuor d’ogni misura.
“Coraggio! – Le dicevano abbracciandola ma senza capire – Vedrai che tutto passa.”
Sapeva ella invece che non sarebbe passato più, e che tutto era senza rimedio, essendole oramai spaventosamente chiaro che quella era l’ultima pietà della gente, l’estremo scampolo di considerazione di cui le era dato godere.
Ma domani?!
Dio mio! Il vuoto di domani!
Quando finalmente riaprì gli occhi, si trovò in una landa senza colori, di ombre più chiare e meno. Lattescenti. Pensò.
Ma non ne fu sgomenta. Era invece affatto tranquilla e in pace, adagiata su una gran poltrona di nuvole, e diafana e leggera come da tempo non le accadeva.
Non vide Dio, né gli angioli che s’aspettava; anzi, per quanto spingesse lontano la vista ora acutissima, non c’era proprio nessuno; non rumori di sorta né cinguettio d’uccelli.
Ma da un punto imprecisato dell’orizzonte senza confini, anzi a ben vedere da ognuno dei punti infiniti di quell’orizzonte, le venivano incontro teneri profumi di caffè; ed ella li respirava inebriandosi, e li vedeva leggeri ma quasi concreti venirle attorno danzando e circondarla, rosei in tanto biancore, a farle festa.
Giunte lì presso, le tenere volute presero a ordinarsi in figure sottili; ed ella non ebbe difficoltà nel ravvisarvi le figlie, che già l’avvolgevano, la carezzavano, le portavano in dono fragranze rosate.
Oh! Il buon caffè!
Una beatitudine totale l’avvolse allora precipitandola nella vertigine… E fu improvvisamente certa che quello era il paradiso.
Cento lunghi anni c’erano voluti per guadagnarselo!
Il suo capolavoro.
Il paese senza carnevale
Riconosco a un tratto il pino troncato cinquant’anni fa da un B.52 abbattuto dalla contraerea, e so, da quello, che dopo la curva vedrò il mio paese.
Eccolo là, infatti: discreto e quasi nascosto in una piega del monte come in un abbraccio.
Ci ritorno dopo quarant’anni, spinto dalla noia d’un giorno storto.
Mia moglie è partita per una vacanza con amici, e io, impedito da impegni e tornato nella casa deserta, mi ci sono scoperto improvvisamente straniero.
Ho tirato giù un libro dallo scaffale, ma ho subito deciso che non me ne fregava niente della peste scoppiata qualche secolo fa in una remotissima regione dell’atlante.
Ho telefonato allora a Mario per vedere d’organizzare qualcosa. Ma figurati! Era già bell’e uscito per chissà dove. E mentre mi crescevano dentro… no! Non proprio un nervosismo, ma piuttosto una scontentezza e una smania intollerabili, mi è venuta l’idea di rivedere il mio paese. Così! Inaspettatamente e per niun’altra ragione se non di quella noia disperante.
A mano a mano che m’avvicino sinusoidando giù verso la valle, ne distinguo meglio, riconoscendole, le mura rossicce e le porte: porta San Paolo, porta Valliva, porta Murata e (la più bella di tutte) porta Fosso Scuro; quella per cui tra poco farò ritorno dopo l’assenza d’una vita.
Quasi quarant’anni da quando ne sono uscito… Ma i primi quindici tra quelle mura sono stati di favola, gli anni certo più spensierati della mia adolescenza: le brigate degli amici, le scorrerie per le vigne, i bagni clandestini giù al fosso… E quand’era la festa del patrono, o a carnevale, allora sì che la giovinezza faceva capriole!
Ci mascheravamo racconciandoci addosso alla meglio un sacco o un lenzuolo, e con pistole ad acqua e salsicciotti di segatura infuriavamo per le strade mettendo in fuga le ragazzine che pur ci venivano attorno provocandoci coi loro gridetti. Ed eran uova farina e borotalco che pitturavano le strade già in festa per una baldoria di coriandoli e di stelle filanti.
Il mio più grosso dispiacere nel partire (lo ricordo bene) fu che per le strade lasciavo inconclusi le grida e i lazzi delle feste carnascialesche. Era infatti di febbraio.
Proprio come ora.
Guarda sul cruscotto il calendario perpetuo: martedì undici febbraio. Perdio! È proprio martedì grasso! Il pensiero gli mette dentro un’allegrezza d’altri tempi, la voglia ritrovata d’un naso rosso e d’andar correndo per le strade.
Ora è sicuro che a porta Fosso ci sarà ad aspettarlo il gran pupazzo di re Carnevale che ride immemore del rogo a lui ogni anno destinato a chiusura delle feste. “Dagli! Brucialo! – Urlava la folla inferocita – Al fuoco!” E lui col sorriso stampato come se non capisse… Poi le fiamme lo divoravano e il sorriso idiota s’invorticava in un ghigno doloroso tra le urla deliranti della gente. Infine si ballava nella grande piazza.
Sì! È certo che lo vedrà, dopo l’ultima curva.
E invece no! Porta Fosso è sguarnita d’ogni allegrezza e spalanca vana la gran bocca di pietra bugnata.
Parcheggio la Golf ritenendomi fortunato di poterlo fare così facilmente e m’avvio a piedi pronto a schivare l’assalto giocoso dei ragazzi.
Ma, dentro, le vie sono deserte… Guardo preoccupato il datario dell’orologio. Non c‘è possibilità d’errore: undici febbraio, martedì, ultimo giorno di carnevale.
Un vento freddo e tagliente di tramontana fischia sui tetti e s’infila a folate in ogni vicolo. I pochi negozi sono tutti serrati e non mi rimane che dirigermi verso il centro. Lì non è certo possibile che…
Ma intanto m’inquieta quel silenzio irreale come s’io fossi sprofondato, per qualche sortilegio, in un incubo senza scampo.
Dov‘è dunque questa maledettissima gente?! E i ragazzi, perdio!? I ragazzi?
Riconosce l’andito dove si scottava alla meno peggio la pasta d’infima qualità, che poi, annerita con surrogato di cacao e salata senza risparmio era servita in pitali quasi sempre scrupolosamente nuovi ai malcapitati costretti ad assaggiarne almeno un boccone… e se sputavano disgusto li si faceva dissetare in canteri di coccio riempiti a mezzo d’una mistura vomitevole d’aceto e tè.
C‘è uno spilungone allampanato che scantona veloce trenta metri più avanti.
Affretto il passo: “Signore!... Signore!” È già sparito in un portone che s‘è richiuso ostile, quasi senza rumore.
Provo ancora: “Signoreee!”
Lo schianto d’una serranda che cade di colpo.
“Signore!” La voce si perde nei vicoli, ma sento che mi fa compagnia.
Continuo a camminare verso il centro. “Signore!” Urlo ogni tanto per esser meno solo.
Con sospetto e sgomento crescenti avanzo guardingo nell’incubo.
Che le coppie, per una singolare convergenza di pensieri, abbiano smesso a un punto di figliare?
Un terzetto svicola sveltamente sotto un porticato… Stanno parlando, ma io non intervengo né provo a rincorrerli; ora so che sarebbe inutile.
Inaspettata però ecco che dal salone di ricevimento del castello Ossuni, quello da sempre riservato ai veglioni, mi par d’udire una musica… “Ecco dove sono!” Trionfo; e senza più incertezze divoro le scale fino al piano nobile.
C‘è festa infatti, ma solo di vecchi incredibilmente grotteschi che ballano un liscio lentissimo, tuttavia scricchiolando come vecchie impalcature: facce scavate da rughe secolari, ridicoli cappellini a cono e risate di cartapesta si muovono ritmondeggiando in un trionfo di ragnatele che calano dai cassettoni lignei del soffitto.
“Signore!” Cerco di fermarne uno che balla voluttuosamente con una scopa: “Vorrei sapere, se può dirmelo, dove sono i ragazzi.”
Con grazia mi s’inchina e, abbandonata la partner, mi piroetta in due-tre volute di danza: “E che ci frega a noi. – Mi soffia in un orecchio – Balliamo, amore! Ora che sei venuto.”
Sono fuori prima d’averci pensato; e finalmente la chiarìa giù in fondo alla stradetta mi fa indovinare la piazza, luogo di tutte le feste importanti; dove alla fine saprò.
L’ansia oramai mi divora e corro mi precipito volo senza ritegno, inseguito dal rumor secco dei tacchi sull’acciottolato.
Nella piazza il riverbero del sole è accecante; ma neppure lì i segni che m’aspettavo: non ragazzi, non coriandoli, non riccioli di stelle filanti rotolati scherzosamente dal vento.
Ho quasi paura ad avanzare; eppure mio malgrado lo faccio, passi pesanti nell’angoscia che sale.
Da una parte c‘è la chiesa di don Ignazio, l’unica porta spalancata.
Mi pare uno scampo ed entro. Non per pregare; non ci penso proprio, né sperando di trovarvi i ragazzi. Quando mai i ragazzi hanno amato le prediche e l’odore dell’incenso?
Si spinge verso l’altar maggiore nel filo di luce bluastra che piove giù dalle finestre bifore, senza più paura, nel silenzio che pur v‘è profondo, ma naturale e buono com‘è sempre quello delle chiese.
Di fianco all’altare di S. Giustino scopre a un tratto il gran Carciofo (così, senza malizia, chiamava da ragazzo il tabernacolo, perché era sorretto da una struttura che tale gli pareva). Ora scopre che non d’un carciofo, ma d’una spiga di grano si tratta, e, perplesso, non sa capacitarsi come mai non prima.
“Cerca qualcuno?” Domanda a tradimento un pretino ossuto snodandosi a fatica dal viluppo nero del banco dell’ombra e della tonaca.
“Perdio!” Salta indietro lui. Giuro che non l’aveva visto finché colui non aveva parlato… E aveva avuto una paura schifosa.
“Cerca qualcuno?” Ripete premuroso sorgendogli a lato.
“No! – Respira appena più tranquillo – Cioè, voglio dire… cercavo don Ignazio.”
“Don Ignazio?!” Aggrotta le folte sopracciglia colui come se dovesse scavarlo chissà da quali macerie; e poi subito spianandosi: “Il mio predecessore. Se n‘è andato più di trent’anni fa… Un brutto male, come si diceva allora. Oggi si direbbe un cancro, un tumore. Sono tempi più diretti, questi, per certi versi.”
“Mi dispiace…” Riesco banalmente a farfugliare.
“E perché mai? – Mi compatisce bonario – Aveva già allora settantatré anni! Muore anche il mare. Dice un poeta… Lorca, se ricordo bene. ...anche il mare. E lei, signore, non se l’aspettava?”
Ora ne avrebbe avuti più di cento, era vero. Eppure, quando era entrato in chiesa, lo immaginava agile come allora: una sessantina d’anni portati con la disinvoltura e la forza delle montagne da cui veniva.
Perché, quando ce ne andiamo, pensiamo che le cose rimangano tali e quali come se, via noi, cessassero di vivere per aspettarci? E invece, un cancro.
“Da allora ci sono io, don Celestino. – Si scusa il prete per consolarlo. – Se posso far io qualcosa…”
La sua disponibilità è così disarmante ch’io cerco in affanno di non deluderlo.
“Effettivamente… da lui volevo sapere, perché è una cosa che m’ha stupito molto, per così dire,... avrei voluto sapere dove sono finiti i ragazzi del paese.”
“Ah! È questo! – Esclama improvvisamente divenuto cordiale – Certo che ci sono. Anche se in giro non se ne vedono. Ma andiamo in sacrestia!” E lo precede con un trottello curioso.
C‘è un gran disordine, e polvere, e libri accatastati in ogni angolo a formar torri tremolanti e sbilenche, eppur ritte; giornali, carte d’ogni genere, un crocifisso di legno annerito, fogli zeppi d’una scrittura sottile, un calamaio con calamo munito di pennino, una zampa di lepre per nettarlo, una tazza colma di grani d’incenso, un pacco di candele e un bidone pieno di moccoli e di colature di cera, un incensiere lucidato a mezzo con accanto un batuffolo di cotone verdastro e secco, fiammiferi bruciacchiati sopra un Sant’Antonio tra i porci, una lattina di coca gravida di matite smozzicate…
“I giovanotti di questo paese? Tutti chiusi in casa, caro mio!”
È diventato gioviale ed ha una gran voglia di parlare: “Gradisce un bicchiere di vino? Di vino vino, voglio dire.” Mi tenta complice.
Ed io sorridendo, senz’altro mi precede: “Venga con me!”
Saliamo su per una scaletta a chiocciola fino a un piccolo appartamento ricavato alla men peggio da una soffitta.
Anche qui c‘è lo stesso disordine, rischiarato però da un gran finestrone senza tende; a che servirebbero del resto?... È la finestra più in alto di tutte sulla piazza.
Da una parete pende la minaccia d’un muso di cinghiale, e su un tavolo sottostante ingrigiscono nella polvere due fagiani, una lepre e un gallo cedrone impagliati.
“Cacciatore!... Lei è dunque un cacciatore?”
“Stato. – Dice il pretino con un lampo d’orgoglio – Un gran cacciatore davvero!” E intanto riempie due bicchieri scovati fuori da un armadietto.
“È un rosolio. – Si vanta soddisfatto – Il vino delle messe. Ma le messe, caro mio! E chi le dice più?! Una volta perfino tre il giorno, ma ora come ora, è grassa se una, che è d’obbligo. E non c‘è un cane che l’ascolti. Il pienone – e scola il bicchiere consolatorio – una – due volte l’anno.
Ma che ci venite a fare? Dico io. Se questa è fede?!... Sono cristiani costoro?...”
Il vino è buono davvero! Ma tutti quegli animali impagliati me lo mandano di traverso.
“E quelli? – Lo provoco – Erano pur essi creature di Dio!”
“È vero! Quanto è vero!... La doppietta tuttavia l’ebbi in eredità da don Ignazio, ed era lustra e ben lubrificata, mi creda! Potevo forse abbandonarla alla ruggine?
Lei, se ho capito bene, non è mai stato cacciatore. – Riprende dopo aver gustato un altro lungo sorso – E dunque non può capire. Come posso raccontarle le mattine nebbiose in palude? E quell’andare libero pei campi? L’odore dell’erba calpestata?... Le stelle?
...un mondo inumidito
dalle distillazioni della notte
una galleria verde e poi
un gran prato,
una raffica di vento e di zagare,
il sussurro delle radici,
la vita che procede…”
Chi era?... Chi diavolo era?!
Eh, sì!... Mi rendo conto che bisogna esser cacciatori… E perciò non voglio convincerla. Vorrei solo farle capire come tutto ciò sia vita.
L’uccidere è solo secondario, un accidente direi… e anch’esso tuttavia è vita autentica, vera, concreta.
Certo! Sono creature di Dio. E sa perché li tengo lì dopo tanti anni?... Per averne rimorso. Per non dimenticare che in giovinezza… Se ne fanno quando si è giovani! E ora li tengo lì: una specie di cilicio moderno.”
Butta giù d’un colpo un altro bicchiere. “Eppure insisto che quella era vita vera..
O preferisce l’altra, dei ragazzi che non riesce a trovare?... Venga! Venga a vedere!” E mi veicola alla gran finestra.
“Guardi bene la piazza!... E guardi adesso tutt’intorno le finestre che vi s’affacciano! Si fa per dire, s’intende, dal momento che sono tutte serrate. Ebbene proprio lì dietro sono i ragazzi che lei sta cercando. Rintanati come topi nelle loro case. E che fanno, vuol sapere? Sono tutti, dico tutti, inchiodati davanti allo schermo del loro computer; e lì mangiano bevono si drogano uccidono fanno l’amore sognano… Senza muovere un passo, tanto che oramai, pur volendolo, non possono più staccarsene. Le gambe sono infatti del tutto inadatte al movimento, ridicole appendici inutili. Storpi. Paralitici.”
“Ma come è possibile? Non s’incontrano più tra loro?”
“Oh, questo sì! C‘è internet: e lì parlano, discutono, giocano.”
“E la scuola?”
“A scuola non vanno più da mesi. Dalla loro stanza si collegano all’istruttore cibernetico che impartisce ad ore stabilite le sue brave lezioni; quelli che vogliono.”
“Questa, almeno, è una bella cosa!”
“Bella un corno! Mi scusi, signore. Ma non c‘è dialogo, e quindi nessuna possibilità per gli uditori di opporsi. E così il maestro diventa autoritario, e fa di loro quello che vuole. Le pare un vantaggio?”
“Ma Dio almeno! In chiesa vengono?”
“Mai.”
“Le sue prediche allora, anch’esse tramite internet?”
“Oh, no! Non ne sarei capace. Mi limito a sperare che attraverso internet si mettano a colloquio con Lui… Che altro potrei fare?”
Sgomento, non capisco più come si possa vivere così.
Tagliato fuori.
È così che si capisce quando è ora di andarsene.
Tento disperatamente di difendermi: “Epperò – dico – chiusi in casa fin quando la primavera non li stani coi suoi umori, e coi suoi fermenti non ne rimuova l’istinto… come dire?...”
“Di fare l’amore? – Sorride dolcemente il parroco – Oh, quello sì! L’amore lo fanno, ma virtuale. Hanno l’interattivo: si scelgono una donna con le misure precise: tanto di vita, tanto di seno… stabiliscono un tempo a piacimento, e lì, via a cavalcare… virtualmente, s’intende!
Amori virtuali, con donne virtuali, con figli e responsabilità virtuali.
Il piacere c‘è tutto, mi dicono in confessione; ma tutto il resto è delirio.
Quando qualcuno, rarissimo, viene a confessarsene, che gli dico io?! Nei comandamenti è scritto ‘Non commettere atti impuri’. Ma sono atti quelli? Sono peccati?
E così non si muovono se non in quel loro inganno: via internet dialogano con tutto il mondo e con nessuno. Conoscono tutte le piante. Lei ha mai visto un baobab? E loro sì! Io non ho mai visto una sequoia; e loro sì. Li vedono sui loro teleschermi come se fossero veri, e vanno per boschi come se realmente calpestassero le foglie e l’erba. Ma è un maledettissimo imbroglio.”
“Ma almeno – provo ancora – se non escono di casa, non fanno però male a nessuno!”
“Lei crede? Non passa giorno, le dico, che sui loro schermi non uccidano, mostri o uomini che siano. E nei modi più crudeli, col sangue che scorre dovunque. E ci godono. Sono malvagi, mi creda!
Quando uno d’essi, di rado, viene da me, io non so che penitenza dargli: un’Avemaria per scrupolo; ma davvero non so se va bene. Perversi. Irrimediabilmente perduti.
Ecco perché le strade sono deserte! Più nessuno. Spariti. Come se… Ricorda la favola del flauto magico? È come se il flautista se li fosse trascinati dietro chissà dove…
Si può sempre sperare che il sonatore sia Dio.
Ma se fosse il demonio?”
Sono sceso in affanno nella piazza calcinata e vuota.
Neppure un volo di rondini. Solo un odor nauseante di zolfo.
Ripercorro quasi di corsa i vicoli verso porta Fosso; ho freddo.
M’infilo in macchina e premo l’acceleratore. Schizzo via giù per le curve: settanta cento mille…
Sto fuggendo. Da che cosa non so; ma è un fatto che in modo aperto, senza la minima ombra di dubbio sto disperatamente fuggendo.
Ho lì davanti don Celestino…
“Ma se fosse il demonio?”
[continua]


