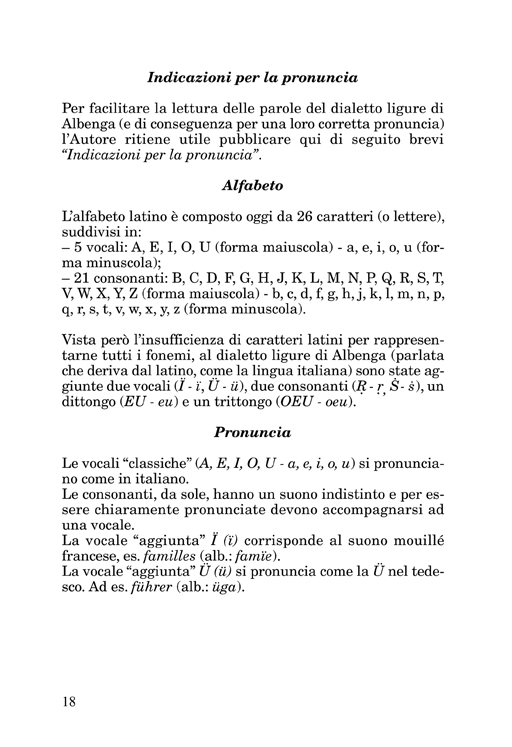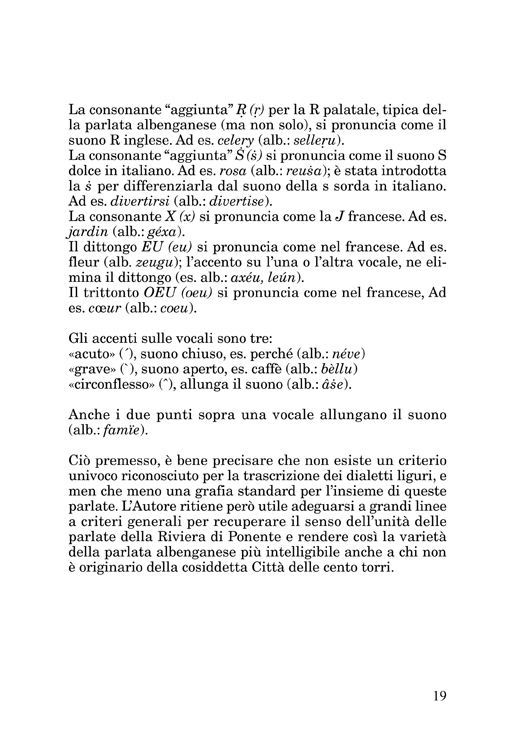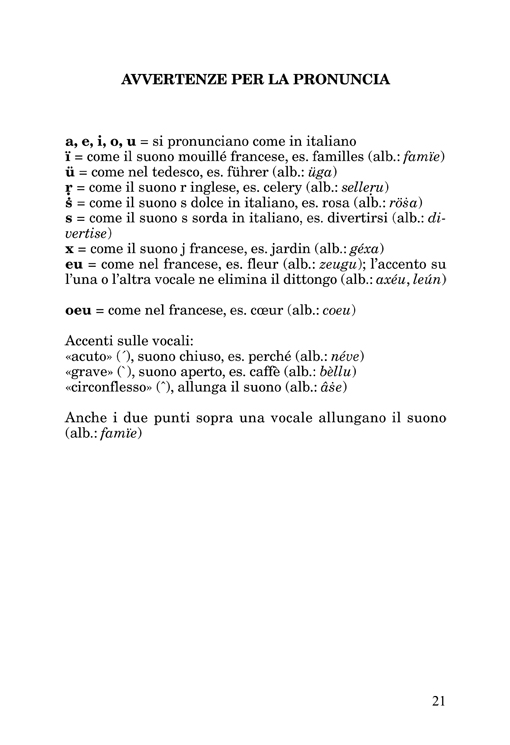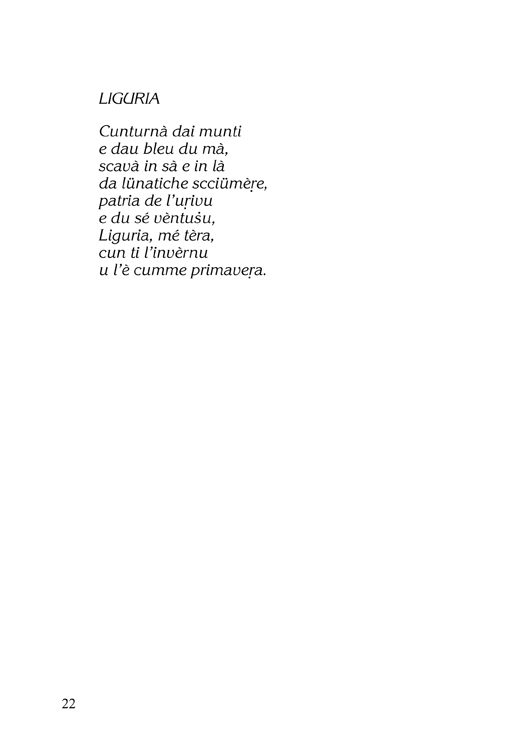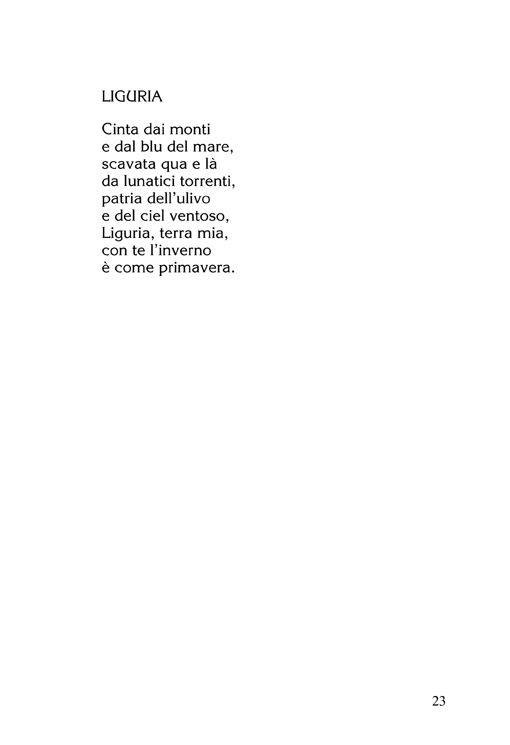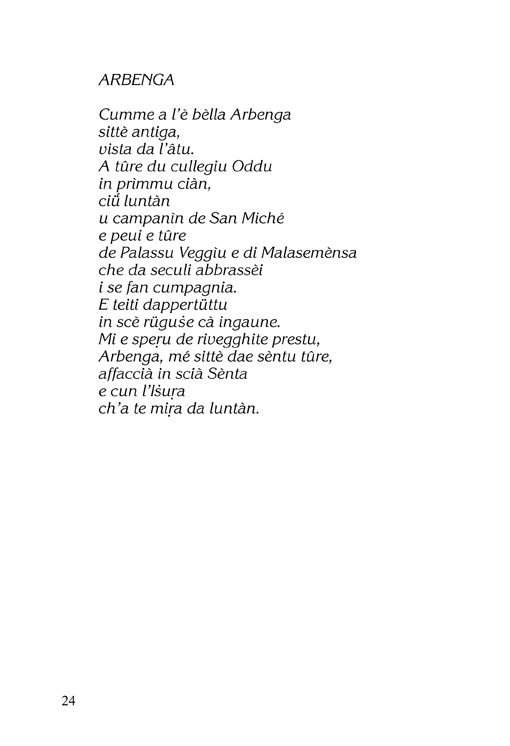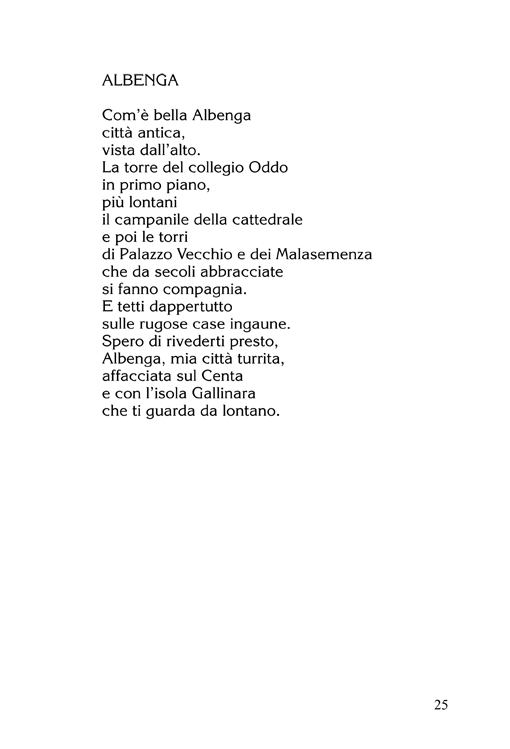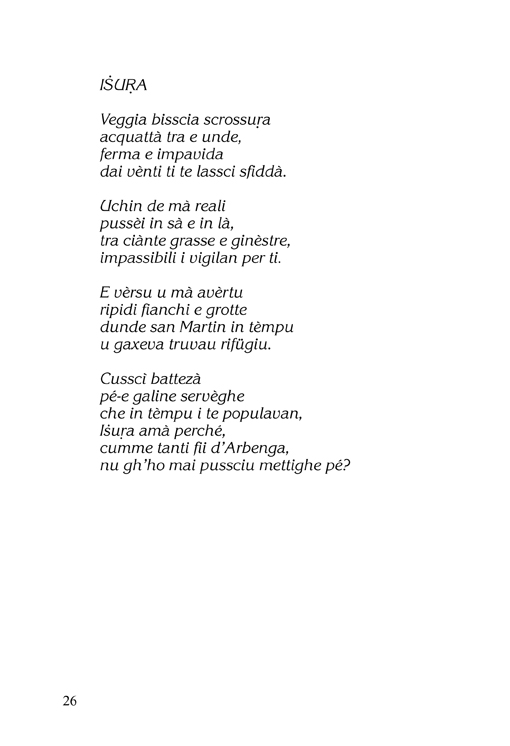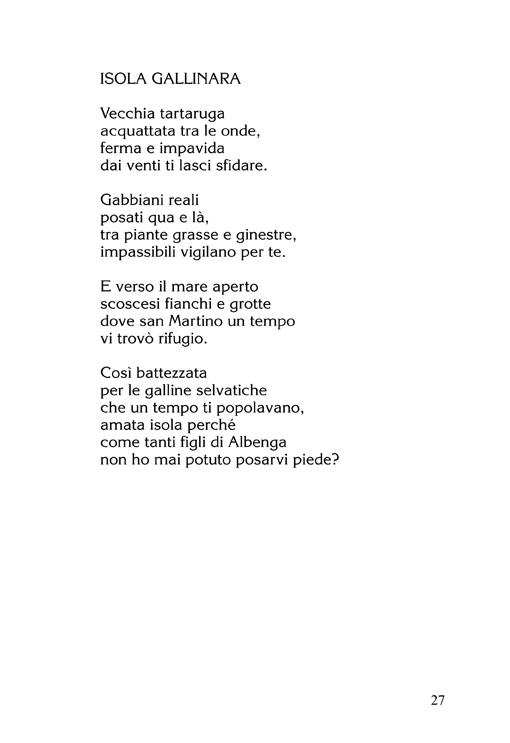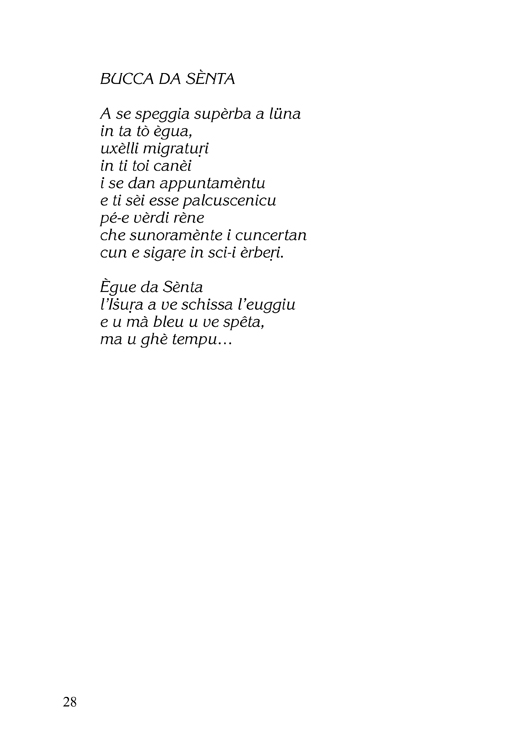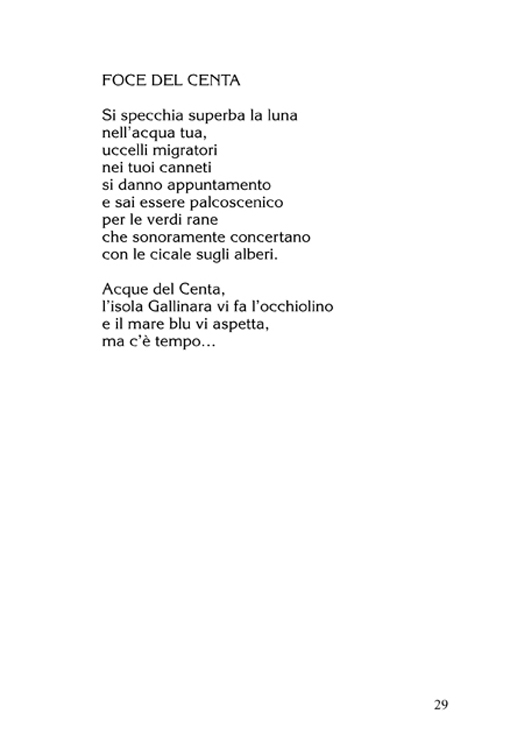Pensceri… parolle (Pensieri… parole)diVincenzo Bolia |
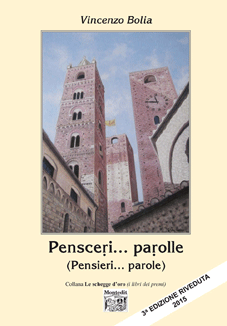
Collana "Le Schegge d'Oro" - I libri dei Premi - Poesia
14x20,5 - pp. 188 - Euro 12,00
ISBN 978-88-6587-5544
Clicca qui per acquistare questo libro
III Edizione ampliata
In copertina: «Albenga, le torri» di Giuseppe Ferrando
Mi è parso significativo, per me stesso come nell’interesse del lettore, riunire in questa nuova e più completa versione del volume le due prefazioni, quella anteposta alla prima uscita e questa, incaricata di accompagnare l’edizione accresciuta di Pensieri… parole, poiché entrambe, consequenziali e integrative l’un l’altra, non soltanto favoriscono la comprensione del senso poetico (e affettivo) che sovrintende alle ragioni ispirative dell’opera, ma costituiscono, insieme, un esaustivo (se pur breve) intervento critico sullo spirito e sull’evoluzione dei miei ‘versi liguri’.
Vincenzo Bolia
PREFAZIONE alla I Edizione
Quasi il verso possedesse una sua coreutica, una forma di percettibile fisicità, un suo andamento gestuale: la parola poetica di Vincenzo Bolia sembra in tal modo sporgersi da se stessa andando incontro alla lettura, mentre si avvolge di persuasiva intonazione e crea un tessuto di carattere emozionale che arriva diretto al fruitore e lo coinvolge. “Un tenue / fil di pianto / io sento / dietro un monte / smarrirsi come un canto / laggiù all’orizzonte. / (…)”, si dice in un passo del libro: sono questi spazi sulla soglia di un’altra nozione di spazio già portatrice di una spazialità metafisica (riflessa, per esempio, in quel qualcosa di tenue, dolorosamente flebile, ma udibile, contro ogni logica del ‘reale’, da “dietro un monte”) a raccogliere gli apici di lirismo dell’autore, per il quale il vero non è che l’aspetto immediatamente riconoscibile del verosimile. Pure altrove, le ampiezze desiderate e realizzate dall’autore trovano una formulazione di inediti effetti: Mare tempestoso ne è un esempio emblematico allorché “scogliera” e “bandiera” divengono due punti di riferimento la cui distanza può essere misurabile solo in termini di vento e quindi di codice poetico.
In un altro caso e contesto, avendo avuto l’occasione di considerare l’opera di Bolia, scrivevo con convinzione dell’“apertura dell’enunciato offerta a plaghe areate, a spazi paesaggistici ora giocati sul dettaglio o sullo scorcio e ora sconfinati, ora descrittivi e ora metaforici”, aggiungendo, inoltre, come tutto ciò, in una prospettiva etico/estetica, sapesse fornire un’attualizzata continuità al clima della ‘scuola ligure primo-Novecento’.
Resto, naturalmente, della stessa idea, anzi, la ribadisco, e sottolineo ulteriormente il legame affettivo e culturale che Bolia ha instaurato con la propria terra; tuttavia, basandomi ora su un più vasto repertorio testuale, sento quelle pur sottoscrivibili indicazioni limitative di fronte a una così vasta istanza poetica. Non vi è, infatti, spazialità di risonanza e d’immagine, nella scrittura di Bolia, che non abbia (anche nella pura referenza, talvolta finanche geografica, delle ampiezze ispirative) un rilievo di marca esistenziale. In altri termini, il poeta guarda e trasforma; il luogo reale si fa luogo della mente (d’altra parte, la Liguria – la sua Albenga – è, per lui, luogo reale e luogo della mente); la coscienza dell’hic et nunc si fa presupposto di linguaggio; e dunque, l’aria e l’immensità, il senso delle cose e l’universo, una montagna e il mare, l’acqua e le tenebre, si fanno infine respiro della parola e dinamica del codice poetico in divenire; e pure il sonno e il sogno, l’illusione e l’assenza, la memoria e la preghiera sono spazi in cui il macrocosmo è riverberato dal microcosmo e viceversa.
La totalità dell’essere in, dell’esistere per, è il progetto primario di questa scrittura in versi, dove niente va disperso e ogni elemento, dal gusto visuale alla seduzione acustica, trova ragione di sé e condensa espressiva nella peculiare accezione di intima cantabilità (tra l’altro, fisionomizzata dalla ‘sinuosità grafica’) che, mentre sovrintende al primo piacere della comunicazione, accompagna la conoscenza della poesia nei meandri nascosti dei significati profondi.
Del resto, Bolia non si accontenta – né si potrebbe mai accontentare – del ‘sentimento semplice’ o univoco. In Staffetta, poesia a un tempo diretta ed enigmatica, si legge: “ (…) / Voi / vivete in me / ed io / in voi / e / il testimone della vita / continuerà / a passar / di mano in mano.” È un passo quasi biblico, ermetico e illuminante nel sostanziarsi all’interno dell’ineluttabile, di un dogma legato ai contenuti della vita. Eppure, alla constatazione si unisce l’accettazione, all’accettazione la scoperta dell’Io negli altri e nel mondo, con le sue implicazioni, i suoi sismi.
Non stupisce che l’illustre autore abbia scritto testi per musica: la musica può, potrà sempre, rivelare intenzionalmente quell’estensione di densità lessicale peraltro già viva sulla pagina; né stupisce che alcune poesie siano previste alla doppia versione, italiano e dialetto albenganese: anche il dialetto – o, forse, soprattutto il dialetto – è una forma di estensione, di ‘espressione radicale’; e poi, nella precisa contingenza, rispecchia appieno quel legame di cui parlavo poc’anzi, ossia afferma quell’unione viscerale e intellettuale, quell’identità assolutizzante tra regione e scrittore che è di nobile origine, di solido ceppo storico, e qui, in un libro come Pensieri… parole, si realizza con la forte incisività dell’appassionato afflato affettivo.
E questo autore, cosa cerca, se non, costantemente, l’espressione radicale del proprio slancio affettivo da trasfondere nell’essenza stessa dell’offrirsi alla poesia?
Rodolfo Tommasi
Prefazione alla II Edizione
Proporre una seconda edizione ampliata di un volume è atto d’amore; significa non aver ancora esaurito, sentire ancora pulsanti, gli effetti di un profondo afflato – emotivo quanto intellettuale – nei confronti della vitalità ispirativi di quel volume così come del contesto in cui è nato, delle ragioni palesi o segrete che gli hanno fornito genesi, humus e accento.
È stato così. Pensce”i.. pa”olle (Pensieri… parole), del resto, è un libro che nell’intimo dell’autore, nelle fibre più interne e vibranti del suo universo espressivo (e lessicale), non è destinato a finire, bensì a diramarsi, ad articolarsi e a riproporsi in nuovi – e pur sempre antichi – territori dell’animo, di quell’animo attivo, creativo, che si spande nella coscienza di essere natura e civiltà, storia e idioma.
E – aggiungerei – luce e ombra di una regione, di quella forse maggiormente dolce e inquietante della penisola, capace di generare gli assordanti sussurri di Camillo Sbarbaro e di ispirare e accogliere i versi altissimi del marradese Campana, ammaliato dallo scavante potere metaforico dei vicoli angusti e degli spazi luminosamente improvvisi: la Liguria.
Quegli spazi, quella luce screpolata e seduttiva, quegli angoli di stratificate memorie che non cesseranno mai di nutrire popolo e poesia, oggi, assai frammentata o finanche esaurita la ‘classicità’ esegeticamente codificata della novecentesca “Scuola ligure”, sopravvivono e si ricostituiscono nella parola poetica di Vincenzo Bolia, saldata alla radice di questa complessa, ardua, quasi iniziatica, ermetica, riservata e pur sempre maliosa e sbocciante regione incantatrice, non tanto come a una madre, quanto nel modo in cui si può restare compenetrati al lampo inatteso e decisivo di un’apparizione, di una rivelazione, spirituale e culturale.
Bolia dedica alla Liguria versi in lingua e in dialetto: ciò ha il valore – abbastanza inestimabile, a pensarci bene – di una doppia assolutizzazione terminologica (senza contare il contributo dato all’imprescindibile sopravvivenza del dialetto, ormai indicato dalla formulazione di “lingua locale”): da un lato, si conduce l’enunciato a un largo raggio comunicativo, se ne offre l’essenza, si continua a far entrare il respiro ligure nella storia letteraria nazionale; da altro lato, tale essenza viene ancora alimentata e intrisa, accresciuta e illuminata e dagli umori della propria genesi, dalla pulsazione del proprio accento caldo di terra marina fatta di vento e di odori. È tutto questo che fa percepire Bolia; è questo che il poeta restituisce all’autenticità della poesia e alla storia.
Nell’introdurre all’edizione precedente, del 2009, di Pensieri… parole, scrivevo (e mi preme ribadire qui): “quasi il verso possedesse una sua coreutica, una forma di percettibile fisicità, un suo andamento gestuale: la parola poetica di Vincenzo Bolia sembra in tal modo sporgersi da se stessa andando incontro alla lettura, mentre si avvolge di persuasiva intonazione e crea un tessuto di carattere emozionale che arriva diretto al fruitore e lo coinvolge.” E, poco dopo, aggiungevo che “il poeta guarda e trasforma; il luogo reale si fa luogo della mente (d’altra parte, la Liguria – la sua Albenga – è, per lui, luogo reale e della mente); la coscienza dell’hic et nunc si fa presupposto di linguaggio”.
Mi sembra evidente – e lo scrivo confermando la sostanza di quelle osservazioni – come l’indagine allora condotta sulla pregnanza di inconfutabili risultati espressivi possa ora assumere, alla luce di questa seconda e ulteriormente arricchita edizione, una valenza di ancor maggiore spicco. La ragione è semplice: Bolia ripubblica, sì, ma estende; estende il repertorio lirico, estende il campo dell’ispirazione meditata, estende la superficie culturale dell’evocazione, estende il suono di una lingua magicamente efficace e puntuale, estende l’amore per la terra dei “lunatici torrenti”, i quali sono anche figurativamente interpretabili come sentimenti, estende le peculiarità di un Io-lirico, le sue ondose o estatiche modulazioni, mirando alla scoperta della purezza prorompente, della parola nuda, dell’attimo fermato dallo stupore della lingua.
Tuttavia, mi sembra giusto chiudere questa nota dando un legittimato seguito alle parole conclusive della prefazione del 2009, quando ponevo a me e al lettore un interrogativo; certo, non scaduto e senza scadenza, poiché Bolia è poeta di sempre più ampi orizzonti, ma oggi invitante a un’affermazione. Dicevo: “E questo autore, cosa cerca, se non, costantemente, l’espressione radicale del proprio slancio affettivo da trasfondere nell’essenza stessa dell’offrirsi alla poesia?” Ora rispondo: l’assimilazione completa e assoluta dell’intenzione all’esito della poesia è avvenuta.
Rodolfo Tommasi
QUANDO UNA RACCOLTA POETICA SI FA POEMA
Evidentemente Vincenzo Bolia spreme e distilla da una plenitudine affettiva e ben consapevole, densa di intimità ma non per questo meno generosa, la ragione della scrittura: dovrebbe essere sempre questa, infatti, l’ellissi ispirativa interiore che accompagna e sostiene la coscienza – e la produzione – di ogni poeta, poiché proprio da ciò scaturisce il senso della sacrosanta e irrinunciabile necessità di ripercorrersi, ripensarsi, riproporsi, di tornare sul già scritto ampliandone le valenze e precisandone le collocazioni emozionali e ambientali; e per Bolia è fondamentale che esse siano anche e imprescindibilmente linguistiche, siano legate alla temperie culturale di una terra e alla presenza fonica che in quella temperie circola e vibra, siano testimonianza d’aria, di acque e di pietra – e insieme calda vita immune da tramonto o decadenza.
Mi fa piacere constatare di essere stato lungimirante quando, introducendo alla seconda edizione di questo che oggi chiamo ‘poema del respiro ligure’, scrissi: “un libro (…) non destinato a finire, bensì a diramarsi, ad articolarsi e a riproporsi in nuovi – e pur sempre antichi – territori dell’animo, di quell’animo attivo, creativo, che si spande nella coscienza di essere natura e civiltà, storia e idioma”.
Così è stato ed è: siamo a una terza, arricchita, ancora maggiormente luminosa edizione; siamo di fronte a un libro avvolgente, carico di sollecitazioni, di lirismo e di rigore, dove ogni piega e plaga di uno spirito viene appunto esplorata e offerta tanto a fondo da far capire che la Liguria (poiché è lei – regione ed essenza umana, radice e imprevedibile fronda – la protagonista assoluta, il perno attorno a cui ruota ogni intonazione del canto) è da comprendere, senza che le due cose possano mai contrastare, come un’ineffabile percezione dell’esistenza (non di rado manifestata – a un passo dall’accezione simbolista – dal versante drammatico) e come una scienza dell’essere.
Del resto, in Bolia tutto è reale e tutto diviene metafora del reale: anche una vecchia tartaruga – emblema di ‘antica presenza’ nel mondo – a cui il verso si rivolge (“ferma e impavida / dai vènti ti te lassci sfiddà”: perché non possono essere intesi come venti umani, venti di incomprensione e di solitudine, segno intorno di un vuoto?) può trasfigurarsi in metafora della poesia: la poesia isola, ma è un previlegio della comunicazione.
È strano, eppure è un dato di fatto, e qui Bolia lo dimostra ampiamente: c’è sempre da far camminare l’idea di espressività su un ponte impervio, scabroso (da affrontare con quel coraggio che tanto piaceva a Rimbaud, stimolandone la propensione eversiva), per far sì che la lingua scopra o fondi il codice della poesia, ovvero si trasformi in linguaggio, in afflato comunicativo anticonvenzionale; il dialetto, al contrario, coi suoi angoli e smussature, le sue densità saporose, i suoi colori fonici, la forza incisiva dei suoi antichissimi moventi pronunciativi, i suoi legami con misteriose naturalità, sembra facilitare il percorso su quel ponte, e finanche annullarlo; vale a dire che è già in sé linguaggio, o almeno fertile fomento di linguaggio. E su tale territorio di significazione Bolia è maestro, dato che ci fa comprendere l’importanza di un universo poetico da nervature di poesia senza tempo e pur modernissime: il suo verso si dirama dalla vocazione non meno che da una tenace – e quanto giusta! – nozione intellettuale del proprio amore.
Ma non mi si fraintenda: Bolia non è (o non soltanto) un poeta dialettale (o, come oggi è più giusto indicare – e in altra occasione l’ho già detto –, di ‘lingua locale’; tanto che il repertorio in italiano è qui ricco e prezioso, visceralmente vissuto in autentiche fibre di invito al coinvolgimento immediato): è piuttosto un poeta che alla lingua locale approda quasi muovendosi tra le correnti di un fascinoso senso mistico, con slancio e al contempo con vigile e sorvegliata mente, individuando in essa la sostanza quintessenziale dell’autenticità; un poeta, insomma, che sa davvero trasfondere in quel ‘parlare dalla pagina’ le età, le ombre, i tratti, le rughe, le sfumature, le espressioni dei visi e dei corpi di chi parla e di chi ha parlato alla storia dalle peculiarità del ‘respiro ligure’ (profondo nell’inquieta, umanissima, e pur sempre plasmante, penna di Bolia).
Cantare una terra attraverso la sua lingua (una lingua fatta di parole e di flessioni tonali, quelle che la buona scrittura evidenzia con naturalezza: parlando di Bolia, infatti, non posso sottrarmi al bisogno di sottolineare l’aspetto musicale del testo e del contesto, perché talvolta certi legami frastici, per esempio, fanno pensare a voci d’oboe o di viola), non significa riprodurre un vocabolario e una grammatica (pur rimarcando l’utilità, anzi, l’indispensabilità, della Nota dell’autore relativa a segni e pronuncia): significa portare a mète di compiutezza il basilare concetto di evocazione, significa evocare dalla voce intima alla ‘voce scritta’, tra le implicazioni e i labirinti argomentativi, tra i temi che si intrecciano, tra le figure che escono dagli angoli della vita e della mente e si susseguono e si incrociano, pure paesaggi e climi, ore del giorno e della notte, solitudini e ombre, luminosità eterne o fallaci, antri celati e pietre, vicoli e mare e rive, linee montane e collinari, vento e stasi d’aria, memorie inestinguibili e pensose, odori e sapori. Ecco, allora, fatalmente sbalzarsi in un inequivocabile primo piano la figura del poeta, di colui che sa (e deve) essere, nel medesimo momento, storico e analista dell’animo, visionario, testimone e profeta, attento cronista del vero ed eletto esploratore del verosimile.
Rodolfo Tommasi
Pensceri… parolle (Pensieri… parole)